
Arbër Agalliu - ©Gezim-it/Wikimedia
L'attivista italo-albanese Arbër Agalliu chiede da oltre un decennio una riforma dell'obsoleta legge italiana sulla cittadinanza, che oltre a rendere la vita impossibile agli aspiranti cittadini italiani, fa sentire moltissimi giovani 'stranieri a casa propria'. Nostra intervista
In Italia, l’acquisizione della cittadinanza è regolata da una normativa che risale a più di 30 anni fa. Si tratta della legge 91 del 1992 , fondata sul sistema dello ius sanguinis, ovvero l’ereditarietà della cittadinanza in base a quella dei genitori. Chi nasce in Italia da genitori stranieri ha la possibilità di fare domanda per acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni, a condizione che abbia risieduto legalmente per tutta la propria vita in territorio italiano. Gli immigrati provenienti da paesi extra-UE, invece, possono fare domanda solo dopo aver trascorso legalmente almeno 10 anni sul territorio italiano.
Nel corso degli ultimi 30 anni sono state presentate oltre 120 proposte di legge per tentare di riformare la legge, ormai ritenuta obsoleta da attivisti ed esperti di migrazioni in quanto risalente a un periodo storico in cui il quadro demografico e migratorio italiano era molto diverso da quello attuale. L’unico tentativo concreto è stato portato avanti nel 2015 dal governo Renzi, ma si è arenato in Senato a causa del sabotaggio di una parte della stessa maggioranza di centrosinistra. Sviluppi che hanno provocato la legittima frustrazione degli attivisti e dei tanti italiani di origine straniera che speravano in una semplificazione del processo per l’acquisizione della cittadinanza e che oggi, con il governo Meloni e la destra al governo, sembra molto lontana.
È di questa opinione anche Arbër Agalliu, giornalista e attivista italo-albanese, da più di dieci anni impegnato nella lotta per riformare la legge sulla cittadinanza e co-fondatore del movimento “Italiani senza cittadinanza ”. Agalliu ci ha raccontato la sua esperienza e le difficoltà di chi come lui affronta o ha dovuto affrontare il processo di naturalizzazione.
Iniziamo dalle tue origini: quando hai lasciato l’Albania e qual è stata la tua esperienza personale relativa al processo di naturalizzazione?
Sono arrivato in Italia insieme alla mia famiglia nel 1998, all’età di dieci anni. Abbiamo lasciato l’Albania dopo il crack finanziario seguito all’enorme schema Ponzi che alla fine degli anni ‘90 lasciò in povertà milioni di albanesi e causò l’anarchia nel paese. Giungemmo in Italia in un momento critico, nel quale c’erano fortissime discriminazioni nei confronti degli albanesi, dovute a una narrazione della cronaca nera in cui eravamo sempre additati come i peggiori criminali. A scuola era più offensivo dare dell’”albanese” che dello “stronzo”. In più, durante l’orario scolastico, i miei genitori mi portavano al commissariato per lasciare le impronte digitali, manco fossi un criminale. Vivere questo status di clandestino già da bambino, in una fase della vita in cui si dovrebbe pensare a tutt’altro, ti lascia il segno.
Oggi ci battiamo perché altri bambini nati o cresciuti in Italia non debbano vivere questo tipo di esperienze. Questo passa soprattutto da una riforma della legge sulla concessione della cittadinanza, in primis per quanto riguarda i minori di origine straniera che in Italia si formano e proiettano la propria vita. Purtroppo, però, sono pessimista. Nonostante gli anni di lotte e investimenti, collettivi e personali, per un’Italia più inclusiva, non vedo una riforma all’orizzonte.
Ora sei cittadino italiano? Quali sono stati gli ostacoli fin qui più difficili durante il processo di naturalizzazione?
Ho ottenuto la cittadinanza italiana nel 2016, dopo 18 anni dal mio arrivo in Italia. Oltre ai lunghissimi dieci anni di attesa, l’ostacolo più difficile nel processo di naturalizzazione riguarda il lato economico: non viene tenuto in considerazione il percorso di formazione scolastico e culturale, ma solo il valore economico della persona interessata. Si merita la cittadinanza solo se si produce ricchezza, se si hanno delle entrate annue tali da permettere di fare richiesta, altrimenti si è destinati a sentirsi stranieri a casa propria.
È intaccato anche il diritto allo studio: chi non è nato in Italia e dopo i 18 anni non è cittadino italiano si ritrova a preoccuparsi non solo di superare gli esami universitari, ma anche di non finire fuori corso, altrimenti rischia di dover trovare un lavoro per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Un’altra questione sono le finestre temporali: se si è nati in Italia, ma si passa troppo tempo fuori dal territorio nazionale prima dei 18 anni, si rischia di vedere bocciata la richiesta di cittadinanza. È il caso di Nadia, una mia conoscente di origine marocchina che durante l’infanzia passava le estati in Marocco con la famiglia, a cui è stata negata la cittadinanza perché aveva passato troppo tempo fuori dall’Italia.
Per alcuni c’è poi il problema della doppia cittadinanza: la Cina, ad esempio, non ammette che i propri cittadini siano in possesso di due passaporti. In questo caso, se un genitore decide di non acquisire la cittadinanza italiana per mantenere quella del proprio paese d’origine, la scelta ricade anche sul figlio, almeno fino al diciottesimo anno d’età. La legge non tiene minimamente conto del vissuto delle seconde generazioni.
Cosa consiglieresti a una persona che sta affrontando il processo di naturalizzazione?
Rompere le scatole il più possibile! Spesso chi fa richiesta rimane a lungo in attesa e anche se vengono infranti i tempi limite non fa pressioni o non prende vie legali per paura di eventuali ritorsioni o un ulteriore allungamento del processo. In realtà è il contrario: il sistema burocratico italiano è un continuo rimpallo di responsabilità, e soltanto attraverso un pressing legale costante si può smuovere qualcosa. Dal punto di vista procedurale c’è poco altro da fare: finché non arriva una riforma siamo ostaggi di una legge obsoleta.
C’è stato qualcosa o qualcuno che ti ha aiutato nel processo di naturalizzazione, e perché?
Se penso alla mia esperienza personale, ho ricevuto la cittadinanza italiana dopo soli venti mesi di attesa dopo aver formalizzato la richiesta, un periodo relativamente breve. Probabilmente ciò è dipeso dal governo in carica in quel momento. Oggi i tempi possono essere molto più lunghi. Onestamente, non mi viene in mente nient’altro.
In cosa consiste la vostra lotta e come la portate avanti?
In quanto immigrati di seconda generazione cerchiamo di far valere il nostro essere figure “ponte”, creando collegamenti a livello internazionale. Io promuovo la cultura albanese in Italia, ma anche quella italiana in Albania, e lotto contro le discriminazioni e per l’inclusione. In tutto questo si inserisce ovviamente anche la lotta per la riforma della legge sulla cittadinanza.
Il nostro è un approccio slegato dalle dinamiche di partito. È diverso dall’attivismo delle prime generazioni: anche loro hanno lottato contro le discriminazioni, ma avevano anche altre battaglie da portare avanti. Oggi ci battiamo per i nostri diritti utilizzando i mezzi che anche loro, facendo i “lavori sporchi” che nessun altro voleva fare, ci hanno messo a disposizione: la formazione, la conoscenza della lingua e quella del sistema burocratico e della società italiana. Siamo italiani al 100%, ma questo ci ha forse penalizzati, in quanto siamo meno “strumentabili” dalla politica. Paradossalmente, le prime generazioni trovavano più consenso e appoggio nei partiti.
Cosa cambieresti del sistema attuale?
Ritengo quasi vergognoso il dover ancora parlare della legge 91 del 1992, dato che molti di coloro che oggi ne sono direttamente interessati non erano nemmeno nati quando è stata promulgata. Si tratta di una normativa totalmente obsoleta, che fa riferimento allo statuto albertino e che andrebbe riformata in toto. È un testo che non considera l’esistenza delle seconde generazioni, dato che ai tempi praticamente non esistevano. Era stato concepito sul concetto dello ius sanguinis, principalmente per richiamare in patria i discendenti degli immigrati italiani all’estero.
Ma oltre alla legge, serve cambiare anche il vocabolario. Essere considerati ancora immigrati di seconda generazione mi sembra assurdo: per molti l’unico processo migratorio è stato quello dall’ospedale dove sono nati a casa loro, in Italia.
Questo articolo è stato prodotto nell'ambito di “MigraVoice: Migrant Voices Matter in the European Media”, progetto editoriale realizzato con il contributo dell'Unione Europea. Le posizioni contenute in questo testo sono espressione esclusivamente degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni dell'Unione europea
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
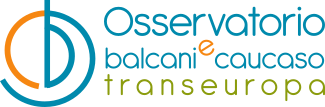






 To Top
To Top