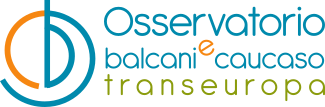L'ingresso del Bunkart2 a Tirana, Albania © trabantos/Shutterstock
Non un libro di storia, ma un libro di “storie”: un collage di racconti di vita reali sotto il regime di Enver Hoxha. E' questo il filo conduttore del libro “L’uomo che non doveva mai morire – l’Albania e il regime di Enver Hoxha” di Giovanni Verga, da poco pubblicato per i tipi di Prospero Editore
Enver Hoxha è un nome che riporta ad anni bui dell’Albania e che oggi è quasi dimenticato...
L’intento del libro è far luce su un personaggio storico poco conosciuto fuori dal suo Paese già quand’era al potere, e sulla sua epoca, che invece ha lasciato un segno profondo nel secondo Novecento europeo.
Il libro si può definire un reportage "nel passato", ricavato dall’incontro con persone che hanno vissuto quegli anni e raccontano come la vita per loro e molti altri fosse diventata una sorta di psicodramma. Allora erano giovani. Quello che si svela nelle testimonianze è l’aspetto “orwelliano” del sistema di controllo della popolazione tramite il Sigurimi, la temutissima polizia politica. A quel tempo si diceva che “anche i muri hanno occhi e orecchie”.
Nessuno ha mai saputo dire con esattezza quante fossero le spie o i collaboratori del Sigurimi. Forse metà dell’intera popolazione. Non ci si poteva fidare di nessuno, chiunque poteva finire denunciato anche dall’amico più fidato, da un collega, persino da un parente stretto. Il regime fondò la sua lunga permanenza sulla paura. Queste persone raccontano come funzionava il sistema delle delazioni, la montatura delle accuse con prove paradossali, i processi – farsa, le grandi purghe.
L’Albania in effetti è stato un Paese isolato dal mondo e avvolto nel mistero...
È stato per più di quarant’anni, durante il regime di Enver Hoxha, morto nel 1985, un luogo inaccessibile: sono famosi i bunker fatti costruire per difesa da un immaginario attacco nucleare.
Poco o nulla si sapeva all’esterno, meno ancora di altri Paesi d’Oltrecortina. È stato invisibile, completamente isolato, recintato in un'auto-apartheid collettiva: non entravano turisti, uomini d’affari, giornalisti, visitatori. Non si entrava e nemmeno si usciva. Un Paese sotto reclusione in piena Europa, ai confini con altri due e a poche decine di miglia dalle coste italiane.
Se ne è invece parlato molto nell’ultimo decennio del Novecento, quando l’esodo di massa di un intero popolo ridotto alla fame e senza una guida politica li portò a migliaia sulle coste italiane. Ora le cose sono cambiate, gli albanesi si sono integrati, ma quel totalitarismo quarantennale ha lasciato delle lacerazioni che non si sono rimarginate.
E le vicende di un regime integralista come forse nessun altro nel secondo Novecento riguarda anche noi, perché in Europa è nato e lì ha le sue radici, in un Paese poi che ha avuto strettissimi rapporti con l’Italia. Quei quarant’anni restano un “buco nero” su cui nessuno sembra interessato a fare luce seriamente. È una lacuna da colmare, senza partire da posizioni precostituite.
Si conferma l’immagine di Hoxha come un despota sanguinario?
Questo non è un libro di denuncia, non è una biografia e ancor meno un saggio di storia. È un libro di “storie”: un collage di storie di vita reali, di “vite degli altri”, raccontate quasi sempre direttamente sotto forma di intervista, che nel loro insieme svelano la personalità distorta di Enver Hoxha e la sua progressiva deriva ideologica e personale.
Come spesso succede in questi casi, la condanna di un leader politico che ha avuto un potere assoluto arriva dopo la caduta. Ma durante quegli anni, non era così. L’opposizione c’era ma era comunque minoritaria, la massa stava con lui. Forse anche solo per paura. Allora è meglio non dare giudizi a posteriori. Quindi nel libro non si usano mai o quasi mai i termini “famigerato” (riferito soprattutto alla polizia segreta), persecuzione, criminale (regime), aguzzini e simili, perché sono di per sé dei giudizi che non devono venire dall’autore ma semmai devono emergere dai contenuti del libro. Inoltre sarebbe stata una ripetizione di cose già dette.
Perché Hoxha era chiamato “L’uomo che non doveva mai morire”?
Era uno slogan della propaganda. Fu ripetuto anche nella oceanica cerimonia del suo funerale nella grande piazza di Tirana dal suo “delfino” Ramiz Elia, che fu il suo successore dopo la morte.
Ma il sistema messo in piedi da Hoxha inevitabilmente non gli sopravvisse, crollerà pochi anni dopo. Nel libro appare chiaro che il suo era un modello del tutto unico, un mix di comunismo e di retaggi della cultura tradizionale e clanica albanese, che non aveva paragoni con gli altri “colleghi” del blocco dell’Est, da Ceausescu a Tito.
Nel libro viene sempre chiamato “familiarmente” solo Enver sia perché lo chiamavano così i connazionali, ma anche per smitizzarne e sminuirne l’immagine enfatizzata dalla propaganda, e facendolo apparire per quello che era: un uomo qualsiasi, un ragazzotto di provincia di poco conto, rozzo e senza doti particolari che finì a diventare capo unico di una piccola nazione per decenni.
Ma anche tutti i testimoni che parlano sono nominati solo col nome di battesimo, senza cognome, come fanno i ragazzi, perché loro erano ragazzi quando si sono visti rubata la gioventù da un regime paranoico.
Oggi l’Albania ha fatto i conti con il suo passato?
Il libro non lo dice esplicitamente, ma fa capire che non lo ha fatto. Emerge dalle storie e dai racconti dei testimoni di quegli anni da incubo. Carlo Bollino, un giornalista italiano che ha ideato e realizzato a Tirana due noti musei sulla dittatura, “Bunk’Art 1 e 2”, scrive nella prefazione che “il ricordo del regime comunista di Hoxha è rimasto ancora oggi una piaga aperta nella memoria degli albanesi, come una ferita mai del tutto curata. Come un lutto non completamente elaborato questa mancata catarsi ha impedito una naturale maturazione del Paese e un definitivo distacco dal passato”.
Maturazione e distacco che invece sono avvenuti in altre realtà simili, come la Germania dell’Est, la Polonia, la ex Cecoslovacchia. L’Albania è ancora un Paese lacerato e diviso sul quarantennio. Lo stesso leader socialista Edi Rama, al governo da oltre dieci anni, è accusato di non voler fare chiarezza sulle responsabilità e sulle collusioni con il passato regime di uomini di potere tuttora in posizioni chiave nelle istituzioni e nello stesso governo.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!