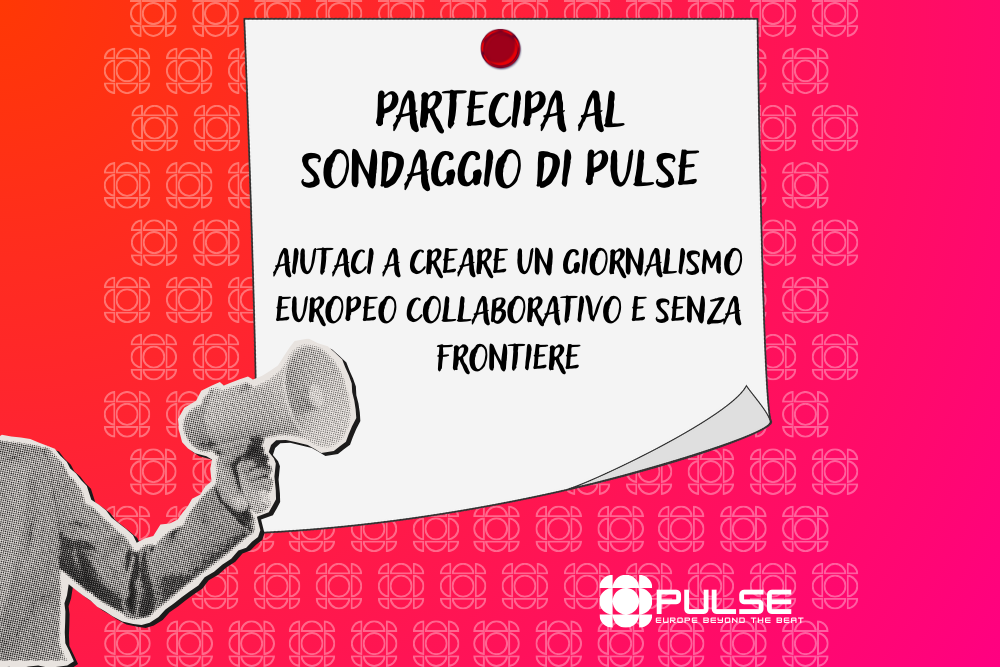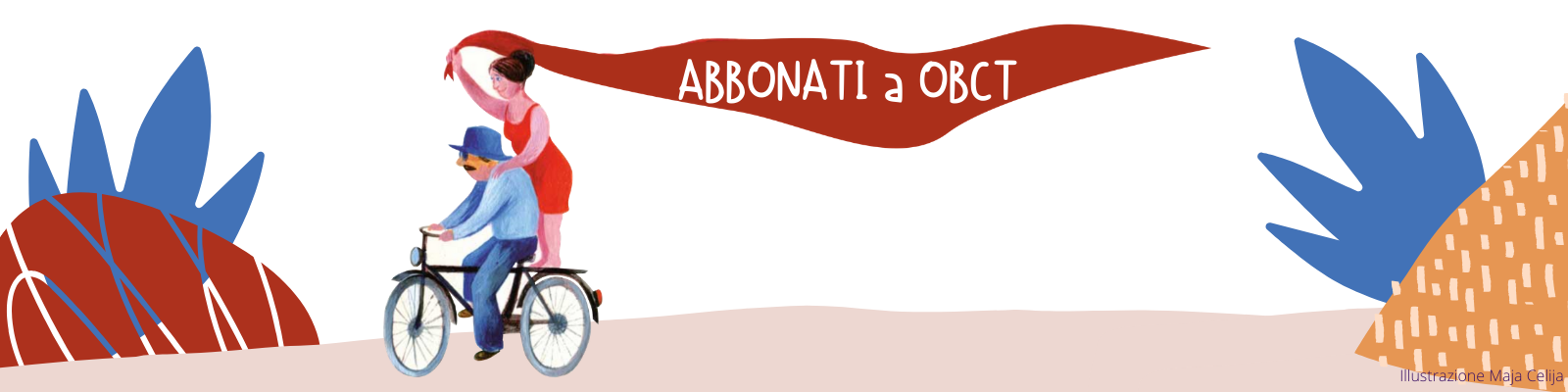Tatari di Crimea, tempi bui
Con l’occupazione russa della Crimea nel 2014, la vita della comunità tatara, storicamente radicata nella penisola è diventata molto più complicata. Ne abbiamo parlato con Ayşegül Aydıngün, professoressa di sociologia e studiosa delle comunità tatare dell’Ucraina

Tatari-di-Crimea-tempi-bui
Tatari di Crimea - © Alexey Pavlishak/Shutterstock
Colonizzazione, deportazioni forzate e repressione dell’identità linguistico-culturale: dal punto di vista della popolazione tatara della Crimea è impossibile non vedere una certa continuità delle politiche russe verso la penisola.
La Crimea fu prima un khanato indipendente sotto protezione dell’Impero Ottomano, poi parte dell’Impero Zarista, in bilico fra autonomia, appartenenza alla repubblica russa e ucraina durante il periodo sovietico, parte dell’Ucraina post-1991 e infine annessa illegalmente dal Cremlino nel 2014.
“È come se gli interessi delle dirigenze di Mosca non siano mutate col passare dei secoli”, ci dice Ayşegül Aydıngün, professoressa di sociologia presso l’Università Tecnica del Medio Oriente di Ankara (Turchia) e studiosa delle comunità tatare dell’Ucraina nonché della popolazione meskheta (etnia turcofona che abitava nei territori meridionali della Georgia).
Aydıngün ha preso parte dieci anni fa a una delegazione turca che si è recata in Crimea per verificare la situazione dei diritti umani dei tatari – l’ultima a poter raccogliere informazioni sul campo.
Nell’anniversario dell’annessione, mentre i report più aggiornati continuano a denunciare una “tragica cascata di eventi e di misure” caratterizzata da una “duratura sofferenza” per la popolazione indigena della penisola, abbiamo ripercorso con lei la memoria di quella visita e ci siamo posti domande su un possibile futuro dell’area.
Ci può raccontare l’operato della delegazione di dieci anni fa? Avevate trovato disponibilità da parte delle autorità de facto della Crimea?
La nostra delegazione era composta da sei persone, tre professori di legge con competenze in diritti umani, uno storico, una giovane professionista che aveva lavorato in Ucraina per molto tempo e che parlava in maniera perfetta il russo e io, che ho una formazione da sociologa e che già ero stata in Crimea diverse volte per le mie ricerche. Per recarci nella penisola abbiamo dovuto ovviamente concordare in maniera abbastanza rigida il nostro percorso, per cui siamo volati in primo luogo a Mosca, poi a Kyiv e infine siamo arrivati a Sinferopoli.
Quello che posso dire, al di là delle conclusioni del nostro report che hanno evidenziato numerose violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione tatara di Crimea, è che una volta che siamo arrivati siamo stati subito accolti da un gruppo di rappresentanti tatari che collaboravano con le autorità che si erano de facto installate con l’annessione e che, in maniera molto poco credibile, ci raccontavano di una situazione rosea ed estremamente positiva. Anche per qualcuno che non avesse una profonda conoscenza dell’area e dell’attitudine della dirigenza russa, era evidente che si trattava di una messa in scena.
Quello che dunque siamo riusciti a fare, per osservare davvero la situazione, è stato dividerci in due, di modo che una parte della nostra delegazione si attenesse al programma preconfezionato dalle autorità e un altro gruppo (tra cui c’ero anche io) potesse effettuare incontri più genuini, grazie alle nostre conoscenze pregresse. Non posso negare che sia stata un’esperienza forte e dolorosa dal punto di vista emotivo: negli occhi delle persone tatare con cui ho parlato ho visto tutta la perdita di speranza, la paura che è subentrata dopo l’annessione russa e, soprattutto, ho sentito quanto dalla loro prospettiva aleggiasse lo spettro di una nuova “deportazione”, stavolta in termini di migrazione forzata.
Insomma, per i tatari di Crimea l’annessione ha rappresentato una cesura molto forte rispetto al precedente periodo sotto la sovranità ucraina…
Dopo la deportazione staliniana del 1944, la comunità tatara è comunque riuscita a conservare una propria identità e a sviluppare una propria rivendicazione del diritto di ritorno in Crimea. Questo nonostante la forte repressione del periodo sovietico e nonostante il fatto che molti membri della classe intellettuale così come delle classi più abbienti fossero stati uccisi. In particolare, sotto la guida di Mustafa Džemilev, hanno creato un movimento di autodeterminazione dal carattere sì nazionale ma comunque animato da un’impostazione universalistica e improntato al rispetto dei diritti umani.
Cosa che ha permesso di concepire il ritorno (iniziato nel 1989, poco prima del crollo dell’Unione Sovietica) come un processo pacifico, che avvenisse nel rispetto della popolazione russa nel frattempo insediatasi in Crimea. D’altronde, non bisogna dimenticare che anche una buona parte della nazionalità russa fu vittima delle politiche sovietiche e fu spinta o costretta a ricollocarsi in aree diverse da quelle in cui vivevano. Ciò non significa che non sussistessero diffidenze o difficoltà e, anzi, fin dagli anni ‘90 il governo russo e i politici filorussi locali non hanno visto di buon occhio il reinsediamento dei tatari nella penisola.
Tuttavia, anche grazie al sostegno dei governi ucraini (i quali, sebbene non avessero riconosciuto da subito i tatari come popolazione indigena della Crimea e sebbene attraversassero spesso forti periodi di instabilità tali per cui non fossero coinvolti profondamente in questioni di questo tipo, erano aperti al dialogo), fino al 2014 il ritorno si è verificato. La comunità tatara è riuscita a ravvivare la propria cultura e la propria lingua, nonché a ripristinare parte del proprio patrimonio sia materiale (monumenti, ecc.) che immateriale e a fondare scuole e media in tataro. Un processo lento e graduale, ma all’opera.
Con l’annessione russa, invece, le pressioni sono aumentate considerevolmente. Le scuole e i media tatari chiusi, libri di testo proibiti così come requisite le proprietà del fondo tataro. In generale, è stato implementato il sistema legale russo come mezzo per spingere verso l’assimilazione: le persone sono costrette a prendere la cittadinanza russa per ottenere accesso ai servizi e ai diritti minimi per la propria sopravvivenza. Chi è o era attivo per l’autodeterminazione tatara viene catalogato come “estremista” e in quanto tale interrogato o detenuto arbitrariamente.
Intravvede un futuro per il ritorno tataro in Crimea?
Purtroppo, mi viene da dire che oramai la questione non ha più solo a che fare con la penisola annessa dalla Russia ma con l’intero sistema globale che, proprio a partire dalla Crimea nel 2014, è entrato in una pericolosissima fase di anomia, di assenza di ordine. L’Europa ha guardato a quegli sviluppi come se fossero qualcosa di marginale, un evento che coinvolgeva popolazioni minoritarie e magari non così rilevanti, quando invece è stato l’inizio dello smantellamento di un’intera architettura di sicurezza, che ora procede a velocità inaudita.
Tag: Minoranze
In evidenza
- Partecipa al sondaggio