
Asmae Dachan - © foto Giuseppe Donghi
Imparare ad ascoltarsi e guardarsi da fuori per vedere e interpretare meglio ciò che ci sta più vicino. Empatizzare con l'altro, con chi consideriamo venire da fuori, da altrove, per conoscere meglio anche noi stessi. Una riflessione sul fare informazione, sui diritti umani e sull'essere migranti
Che cosa può portare al dibattito pubblico, lo sguardo e la voce di chi ha “altre” radici? Ascoltare la lettura e l’interpretazione dei fatti da persone con esperienze e background diverso offre una visuale ampia, policroma e allontana il rischio di narrazioni piatte e pressoché simili.
In Siria, ai tempi della Guerra Mondiale, si usava un modo di dire, “Sintonizzarsi su Radio Londra per sapere cosa succede a casa nostra” per indicare la possibilità, ma anche la necessità, di guardarsi e ascoltarsi da fuori per vedere e interpretare meglio i fatti di casa propria.
Uno sguardo esterno, libero da condizionamenti, propaganda e censura, era considerato uno strumento importante per approfondire la realtà locale. In questo caso una radio straniera, quando ancora non esisteva internet e la stampa era controllata dal regime, rappresentava una boccata di ossigeno.
Questo principio risulta utile anche oggi, declinato non solo alle società dove non esiste la libertà di stampa e di espressione, ma anche alla realtà del giornalismo in generale. Chi guarda da lontano ha una visuale più ampia, una sorta di grandangolo che permette una visione di insieme, ma questo a patto che la distanza sia una condizione momentanea.
Il giornalismo di prossimità, quello che porta nei luoghi, a respirare l’aria di un certo posto, ad ascoltare voci, a vedere con i propri occhi i protagonisti e i fatti che accadono altrove è fondamentale per una buona qualità dell’informazione.
Proprio come in fotografia, avvicinare e allontanare l’obiettivo è un esercizio necessario per chi vuole fare cronaca, analisi, ricerca. Ricevere notizie di agenzia è utile, velocizza i tempi di diffusione delle notizie, ma basarsi solo su queste veline rischia di abbassare la qualità del lavoro e appiattire i dibattiti che ne conseguono.
Non è raro, infatti, leggere prime pagine di giornali anche ideologicamente diversi che sono quasi dei fac-simile e a volte persino i titoli e i contenuti degli articoli sono di fatto identici.
Avere sul posto un corrispondente locale offre una visuale privilegiata, che permette una lettura dei fatti approfondita e unica, ma anche avere qui una persona, un professionista che da quei luoghi viene, che conosce quelle dinamiche, quei codici, quei gesti, quelle storie permette di avere una chiave e una via di accesso uniche.
Pensiamo al grande contributo che può rappresentare in questo momento, ad esempio, la voce di una persona siriana o di origine siriana che racconta e analizza la guerra, la caduta del regime, la fase di rinascita nel Paese mediorientale rivolgendosi a un pubblico straniero confuso e stanco di ascoltare una narrazione spesso paternalista e viziata da uno sguardo per molti versi coloniale.
Sarebbe però limitante pensare che una persona di origine straniera possa essere interpellata solo relativamente ai fatti di quella terra, ignorando quello che può dare la sua voce sulle questioni italiane e internazionali.
A volte si crede, infatti, che una persona con radici lontane possa essere utile in modo relativamente limitato, da coinvolgere solo su temi come la migrazione, la guerra, l’"integrazione", la cittadinanza, l’interreligiosità, ma il contributo che può dare in realtà si estende a molte altre questioni legate ai diritti umani, all'ambiente, alla giustizia, alle problematiche sociali ed economiche. Questo perché ogni individuo ha dentro di sé un mondo da esplorare e condividere, un’unicità che lo fa emergere e lo rende unico.
Ogni singola vita è preziosa e irripetibile. Un concetto che non è mai scontato, soprattutto oggi, dove invece si è tornati ad ascoltare discorsi aberranti, che non danno valore alle vite altrui. Non è solo chi fa apologia di guerra che nega tale valore.
Il ritorno di discorsi nazionalistici e suprematisti sembra indicare che non tutte le vite abbiano lo stesso valore e che solo chi nasce in un determinato luogo, luogo da cui vengono anche i suoi avi, e in esso resta per sempre abbia una legittimità di esistere, mentre chi nasce in un luogo e da questo si sposta, sembra perdere il suo valore intrinseco. Pensiamo, ad esempio, a termini come “migranti”.
Le cause del migrare sono molte, dalla povertà alle crisi climatiche, dalle guerre alle necessità economiche. Ci si muove dalla notte dei tempi e nulla può fermare questo fenomeno, che però viene sempre raccontato in modo emergenziale e persino criminalizzante.
Il migrante, i migranti, nell’immaginario collettivo non sono persone “normali”, sono portatori di problemi, numeri da gestire. Sebbene l’atto di migrare sia, come ogni fenomeno umano, temporaneo, con una durata che può essere breve o lunga, alcune persone vengono etichettate per tutta la vita come migranti, immigrate, straniere, a prescindere dal tempo che poi le vede risiedere in un determinato luogo.
Sembra persino che questo fenomeno, la migrazione appunto, sia eterno ed ereditario, tanto che si parla di seconde e terze generazioni, riferendosi all’origine “diversa” appunto dei figli, nipoti e pronipoti di queste persone.
Il fenomeno poi, assume anche contorni ideologicamente pericolosi, come quando si arriva a parlare di “sostituzione etnica”, riferendosi ai bambini nati in un determinato Paese, ma originari di un altro, che andrebbero a “rimpiazzare” il calo delle nascite che in questo momento colpisce, in particolare, le società occidentali. C’è chi ha alzato ulteriormente il tiro, arrivando a definire i figli di coppie straniere come “sostituti etnici degli aborti delle donne occidentali”, in un mix tra razzismo e maschilismo tossico.
Chi usa questo linguaggio, tra le altre cose, non tiene conto dei traumi che simili dichiarazioni possono provocare in chi subisce questo tipo di etichettatura. Sentirsi chiamare sostituto etnico di un aborto può fare molto male, anche se di certo qualifica chi usa questi concetti e non chi li subisce.
È importante per questo non dare mai nulla per scontato e non limitarsi a fare spallucce, lavorando con le nuove generazioni per favorire la conoscenza, il dialogo, un atteggiamento costruttivo verso un mondo che cambia rapidamente e in modo inesorabile.
È altresì importante però parlare con le fasce più mature delle popolazioni occidentali, che comprendono il numero maggiore di cittadini e hanno un potere decisionale ed economico maggiore rispetto ai giovani, perché smettano di parlare di migrazione sempre e solo in modo negativo e strumentale.
L’empatia e l’onestà sono imprescindibili per affrontare lealmente tutte le questioni legate ai diritti umani, come la migrazione appunto. Risintonizzandosi oggi su Radio Londra forse, tra le altre questioni, si sentirebbe parlare anche di quei tantissimi giovani italiani che stanno lasciando il proprio Paese per destinazioni estere. Non sono perseguitati, non sono vittime di guerra, ma partono in cerca di opportunità.
Nessuno direbbe di loro che sono migranti economici, anche se in molti decidono di cambiare vita proprio perché sono alla ricerca di luoghi e situazioni dove ne vengano riconosciuti meriti e qualità e vengano date loro maggiori opportunità. Tutti riconoscono loro il valore aggiunto che portano lì dove vanno. Nessuno li criminalizza. Ecco, questa sarebbe una trasmissione da ascoltare e da cui imparare.
Asmae Dachan è giornalista professionista, fotografa, poeta e scrittrice italo-siriana. Esperta di Medio Oriente, Siria, diritti umani, Islam, dialogo interreligioso, lavora come freelance per diverse testate nazionali e internazionali. È creatrice e autrice del blog "Diario di Siria – Scrivere per riscoprire il valore della vita umana ” e dei podcast “Siria, guerra e gelsomini ” e “Nelle nostre case”. Nel 2019 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Questo articolo è stato prodotto nell'ambito di “MigraVoice: Migrant Voices Matter in the European Media”, progetto editoriale realizzato con il contributo dell'Unione Europea. Le posizioni contenute in questo testo sono espressione esclusivamente degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni dell'Unione europea.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!
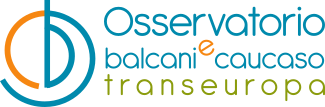







 To Top
To Top