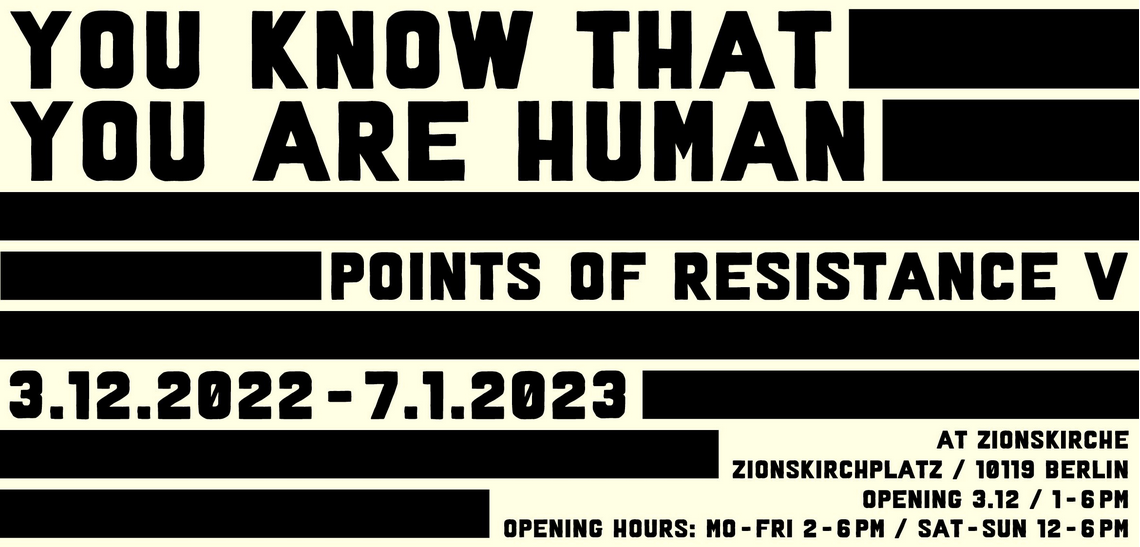
Il manifesto di un'iniziativa promossa da Izolyatsia
"Il nostro compito non è quello di 'correggere' le persone o quello di dire loro cosa devono pensare, piuttosto dovremmo essere capaci di offrire un'idea credibile di futuro insieme". Mykhailo Glubokyi è tra gli animatori dello spazio culturale Izolyatsia, fondato a Donetsk e poi trasferitosi a Kyiv. Lo abbiamo intervistato
Quando la storia sembra ripetersi: i membri di Izolyatsia – associazione culturale e artistica che nel 2014, alle prime avvisaglie della guerra del Donbass, fu costretta a trasferirsi da Donetsk perché la sua sede fu occupata dalle forze separatiste e poi trasformata in una prigione – non immaginavano certo di dover affrontare difficoltà simili a otto anni di distanza. Invece, com’è successo a tanti altri, con l’invasione russa del 24 febbraio anche il loro nuovo spazio a Kyiv – situato presso un ex-cantiere navale nei pressi della penisola Rybalski sul fiume Dnepr che attraversa la capitale – è stato temporaneamente chiuso e lo sforzo collettivo dell’associazione si è ri-orientato per far fronte alle necessità primarie generate dal conflitto e verso la «resistenza del paese contro l’aggressore» (come recita il comunicato che ancora campeggia sull’homepage del sito).
In un momento come questo, il punto di vista dei membri di Izolyatsia è oltremodo interessante. Non solo perché la loro provenienza e le loro precedenti attività nel Donbass li rendono capaci di leggere più nel profondo alcune dinamiche in atto nelle “repubbliche popolari” e di collegarle alla guerra attualmente in corso, ma anche per capire come la cultura e la società civile potrebbero giocare un ruolo in termini di pacificazione e ricomposizione sociale nei tempi a venire. Ne abbiamo parlato con Mykhailo Glubokyi, uno degli animatori dello spazio.
Cosa avete pensato il 24 febbraio?
Non immaginavo che sarebbe iniziata una guerra su larga scala. Avevo molti progetti aperti, con molti partner molto spesso europei e a tutti dicevamo che non c'era da preoccuparsi. Ciononostante, allo stesso tempo, ci preparavamo all'eventualità remota che la guerra avvenisse: anche sulla scorta della nostra esperienza del 2014/15 ci siamo dunque occupati di mettere in salvo informazioni e materiali che in caso di emergenza sarebbero potuti andare persi, abbiamo nascosto documenti, creato copie di fotografie e video, ecc.
Chiaramente, il momento in cui l'invasione è partita è stato vissuto in maniera diversa dai diversi membri dell'associazione. Ma per tutti è stato uno shock e nessuno di noi sapeva bene come agire, almeno nel corso delle prime due settimane. Nel 2013, quando il nostro spazio in Donbass era stato per la prima volta preso d'assalto dalle forze separatiste, la prima cosa che abbiamo fatto fu cercare di avere visibilità per raccontare la nostra esperienza e denunciare l'accaduto. In qualche modo, è stato ciò che abbiamo fatto anche questa volta: infatti, lo stesso 24 febbraio quando ho guidato da Kyiv verso l'ovest dell'Ucraina con la mia famiglia, mi fermavo lungo la strada per parlare con persone di radio e media diversi perché mi sembrava importante lasciare la nostra testimonianza e far uscire più informazioni possibile.
Il fatto che si sia verificata un’invasione su larga scala vi ha fatto in qualche modo vedere sotto una luce diversa gli eventi del Donbass di otto anni prima?
No, per niente. Anzi, ti posso dire di più: già nel 2012 avevamo ospitato un'artista dalla Crimea nel nostro spazio a Donetsk con un progetto di grande successo (Homo Bulla di Maria Kulikovska, ndr). Poco dopo, nella sua città d'origine l’artista ricevette delle minacce per via del carattere femminista e queer delle sue opere e decidemmo allora di accoglierla da noi, per garantirle un posto sicuro (dopo il sequestro della sede di Izolyatsia da parte dei separatisti, le sue opere sono state distrutte, ndr). Quindi è come se per noi il tutto fosse già iniziato allora, abbiamo avuto un sentore di ciò che sarebbe potuto succedere. Tuttavia, mai avremmo creduto che simili dinamiche si sarebbero estese pure nel Donbass.
La mia sensazione, dunque, è che quello che sta attraversando l'intera Ucraina in questo momento stia in realtà andando avanti da otto anni, ma ora in scala molto più ampia. A maggior ragione dato che abbiamo lavorato spesso, dal punto di vista culturale e artistico, con persone che vivevano o si trovavano vicino alla linea di contatto oppure nei territori occupati. Questo ci ha permesso di ricevere informazioni approfondite e mantenere consapevolezza su quale fosse la situazione lì e il fatto che a un certo punto la Russia avrebbe deciso di riconoscere le repubbliche popolari e di annettere quei territori era un'eventualità sempre all'ordine del giorno e discussa. Pertanto, non c'è stata da parte nostra alcuna re-interpretazione di quanto avvenuto nel 2014/15: l'escalation si è infine avverata nelle modalità che avevamo potuto prevedere già tempo addietro.
Che idea vi siete fatti della quotidianità nei territori occupati?
Un paio di anni fa, siamo riusciti a mettere in piedi un progetto di musica itinerante che aveva la propria tappa finale a Severodonetsk a cui hanno partecipato artisti provenienti dalla regione di Luhansk. Qualcosa che ovviamente non abbiamo pubblicizzato in alcun modo, proprio per evitare di mettere a rischio chi vi avrebbe preso parte dai territori occupati. In generale, è davvero difficile ottenere informazioni sicure e credibili da quell'area: chi decide di esporsi pubblicamente, di solito, non lo fa per dire quello che pensa veramente, ma si limita a riferire cose che non lo mettano in pericolo.
Ma credo occorra considerare il fatto che la maggior parte delle persone che sono rimaste lì sono persone poco impegnate politicamente, che cercano di adattarsi alla situazione circostante. Al di là di questo, la possibilità di esprimersi liberamente è molto limitata: anche l'arte non esiste in maniera indipendente, ma solo se rigidamente controllata e finanziata dalle strutture statali che sono state istituite in quei territori. Il ministero della Cultura locale ha un programma specifico che segue linee di propaganda politica. Ora questa situazione è aggravata dal fatto che c'è una forma di mobilitazione generale per far fronte alla guerra. So di persone che si sono sostanzialmente barricate in casa per mesi, nel timore di essere coscritte, fino a quando sono riuscite a corrompere qualcuno e scappare in Europa passando per la Russia.
Che tipo di reazione avete incontrato negli anni scorsi presso la società ucraina per le vostre attività, quando la guerra del Donbass era ancora in corso?
Penso che abbiamo una buona reputazione e, dalla nostra prospettiva, non abbiamo mai avuto problemi né abbiamo sperimentato pregiudizi nei nostri confronti, né a livello di associazione né a livello personale. È vero che esistono atteggiamenti di alcuni che tendono a vedere chiunque arrivi dalla regioni dell’est come un “separatista” o un “traditore”, ne abbiamo sentito parlare e abbiamo ascoltato diverse storie a riguardo. A ogni modo, uno dei nostri obiettivi era proprio quello di far conoscere la nostra prospettiva anche nei luoghi in cui la guerra era solo una realtà lontana.
Tuttavia, mi hanno colpito alcune reazioni dopo il 24 febbraio dello scorso anno: varie persone ci hanno detto, a seguito dell'invasione su larga scala, che finalmente avevano capito che cosa avevamo vissuto noi del Donbass. Per me è stato strano, in una certa misura, perché fino a quel punto ho sempre pensato che comunque fossimo tutti sulla stessa barca. Ma è chiaro che, finché non si passa per un'esperienza personale, la consapevolezza non può essere la stessa.
Pensate che in futuro ci potrà essere una reintegrazione pacifica di quelle regioni nel territorio ucraino?
Si tratta chiaramente di una questione molto complessa. Nel 2014 e 2015 sarebbe stato più semplice rispondere, ma via via che il tempo è trascorso le cose si sono ulteriormente complicate. Il punto è che la situazione cambia continuamente: a un certo momento, in qualità di associazione, pensavamo fosse necessario elaborare un programma per punti su come avremmo visto la possibilità di una reintegrazione pacifica del Donbass nel paese ma, appunto, il contesto muta di giorno in giorno e abbiamo capito quanto sia difficile immaginare un processo concreto.
Intanto, la propaganda russa diventa sempre più forte ed entra sempre più a far parte dell'identità della popolazione. Abbiamo contatti nel Donbass con cui possiamo parlare liberamente, ma ci sono alcuni punti ed elementi che diventano ostacoli e su cui è quasi impossibile ragionare assieme. Si tratta chiaramente anche di una forma di autodifesa per chi vive sotto occupazione da anni e costituisce il loro modo di intendere la realtà. Ma a questo proposito il nostro compito non è quello di "correggere" le persone o quello di dire loro cosa devono pensare, piuttosto dovremmo essere capaci di offrire un'idea credibile di futuro insieme. È un obiettivo difficile, ma si tratta di ciò a cui dobbiamo puntare e spero potrà essere possibile. È addirittura più difficile se pensiamo agli adolescenti che sono cresciuti nelle repubbliche popolari e magari non hanno contatti con altre persone in altre parti dell'Ucraina.
Credete di poter giocare un ruolo in questo processo, come associazione?
Per noi è assolutamente fondamentale, e per due ragioni specifiche: vogliamo tutelare il più possibile la libertà d'espressione; crediamo che la prospettiva artistica-culturale di lavorare con le esperienze personali in maniera non intrusiva possa essere di grande aiuto. Si tratta del motivo per cui abbiamo per esempio collaborato con associazioni attive nel contesto jugoslavo che appunto si occupano delle riappacificazioni post-belliche. Poi abbiamo timore che lo stato non riesca a gestire propriamente il processo in questione: negli ultimi otto anni non è riuscito a farlo per via di una mancanza di saper-fare e per l'eccessiva burocrazia che lo caratterizza. Le associazioni indipendenti, invece, hanno molta più possibilità di successo in questo tipo di situazioni.
Per noi, che oramai abbiamo un'esperienza di tredici anni in questo campo (qualcosa di non così usuale nel panorama ucraino), la missione importante però non è solo fare parte individualmente di questo processo, ma mettere a disposizione la nostra conoscenza per altre associazioni, gruppi e collettivi. C’è un terreno più fertile di quel che si pensa: se guardiamo ai territori del Donbass non occupati vediamo come il contesto sia totalmente differente da quello che si poteva trovare nel 2014. Ci sono tante persone attive socialmente, nonostante si tratti spesso di città e villaggi in cui il lavoro rappresenta quasi l'unica occupazione della gente e l'unico orizzonte di realizzazione esistenziale. Otto anni dopo la guerra, si può vedere come in quasi ogni centro ci siano spazi comuni, organizzazioni attive, interesse da parte della popolazione nel costruire una nuova identità e capire quali possano esserne i nuovi pilastri... a Mariupol, per esempio, si sono esplorate le radici greche e tatare della città, prima della guerra stavano per nascere nuovi musei.
Davvero, direi che c’è stata un'ondata di iniziative autorganizzate. Qualcosa che era iniziato anche a Donetsk nel 2012, ispirandosi a una sorta di "modello tedesco" che faceva tesoro dell'eredità degli spazi industriali ed era davvero promettente... Da una parte dunque tutto ciò ti dà la speranza che sia possibile tornare a questa atmosfera di costruzione di una nuova comunità, influenzata dal passato industriale, europeo e sovietico allo stesso tempo. Dall’altra parte, parliamo appunto di un processo che non può essere calato dall'alto e gestito unilateralmente dallo stato. Al contrario, si tratta di un lavoro quotidiano, il più possibile indipendente e libero, che deve coinvolgere le persone dal basso e valorizzare le esperienze specifiche e connetterle con dei valori condivisi. Solo così si potrà ottenere un risultato duraturo. Credo davvero che, contrariamente a quello che può sembrare, ci sia un desiderio diffuso di mettere in moto e far progredire tali dinamiche.
Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!

















 To Top
To Top