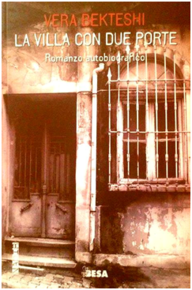Un romanzo autobiografico sulla vita durante il regime di Enver Hoxa, in Albania: dal quartiere della dirigenza, nel cuore di Tirana, all'isolamento in sperduti villaggi. Una recensione
Vera Bekteshi è oggi un’affermata scrittrice albanese. Figlia di un generale dell’esercito, che è stato anche Direttore dell’Istituto di Studi Militari, durante il regime di Enver Hoxha, cresciuta a Tirana in quello che viene chiamato il “Blocco della dirigenza “, cioè il perimetro della capitale riservato agli alti papaveri del regime, divenne a un certo momento vittima dello stesso. E non per merito o demerito suo, giovane donna allora, studentessa di fisica all’università, bensì, semplicemente, per essere figlia di un uomo improvvisamente accusato di complottare contro Hoxha.
Il padre venne arrestato e condannato, insieme a tutta la famiglia, moglie e figli compresi, all’isolamento in tre successivi villaggi dell’Albania, uno più sperduto dell’altro. Un internamento che sarebbe durato ben 16 anni, fino alla morte del dittatore e la caduta del regime, anni segnati dal cambiamento di status, ovviamente, e miseria e malattie, oltre che vessazioni di ogni tipo, a cominciare da un controllo asfissiante con microfoni nascosti nelle case in cui vivevano, in un uso contingentato dell’energia elettrica, dell’acqua, del latte (200 grammi a famiglia) e del lavoro coatto nei campi.
Vera Bekteshi racconta tutto questo nel romanzo autobiografico, come l’ha voluto definire, “La villa con due porte” (edito da Besa, nella traduzione di Valentina Notaro), ovvero la casa a tre piani e tre appartamenti, uno per ogni papavero, da cui – come élite del regime – erano partiti dopo la condanna per non tornarvi mai più e restare, nei ricordi della scrittrice, come il ricordo più dolce della sua infanzia e adolescenza.
Una villa in cui Enver Hoxha, nel romanzo mai nominato e indicato come il Dirigente era talvolta ospite, così come la moglie di questi, Nexhimije, con la quale erano in amicizia. Naturalmente, un’amicizia sempre caratterizzata dal distacco che il ruolo imponeva nei rapporti tra il dittatore e i sottoposti, e che è ben espresso attraverso il racconto di una piccola diatriba matematica tra la studentessa Vera e il Dirigente, quando questi un pomeriggio venne a prendere un tè a casa loro. Vera, giovane ingenua e spontanea non esitò a dire ciò che pensava e che, però, non corrispondeva esattamente al pensiero del dittatore. Il quale, scrive, “fissò su di me i suoi occhi, dai quali si irradiavano migliaia di scintille di rabbia. Rabbrividii in tutto il corpo, la voce mi rimase in gola e proprio allora capii da sola, sulla mia pelle, cosa significasse avere a che fare con lui. (…) Senza saperlo, avevo toccato un suo punto debole, cioè il tabù dei suoi studi incompiuti”.
Del carattere di Hoxha e del suo cinico modo di governare, indifferente alle amicizie e solidarietà, molte delle quali risalivano alla comune lotta contro il nazifascismo, preoccupato solo della detenzione del potere e del controllo su ciascuno dei suoi uomini, tutti praticamente spiati, queste pagine danno un impressionante ritratto in chiaro scuro.
E’ indubbio che in questo romanzo la parte più personale e intima, cioè la vita così come si svolse nei sedici anni di internamento, dal 1974 al 1990, con il ritorno a Tirana nel 1991, abbia i suoi forti motivi di interesse, perché porta la testimonianza, da una parte, dei forti condizionamenti della vita degli uomini posti da un potere assoluto, e dall’altra la capacità degli uomini di saper trovare, nella disgrazia, nella vita grama, nella sofferenza, piccole gioie, che possono essere rappresentate da un fiore, una carezza, la pagina di un libro. Di libri che si potevano leggere, ovviamente, a dispetto della furia che, nel periodo di imitazione della Rivoluzione di Mao, portò alla “eliminazione dei libri decadenti in biblioteca (si salvarono solo i classici antichi e i testi accademici)”, accanto ad altre forme di isteria sul piano del costume come il rogo delle minigonne, il taglio delle basette, così perentorio che all’aeroporto di Rinas, l’unico internazionale del paese, venne istituito un barbiere che “rasava ogni straniero che entrava in Albania e che poteva dare un cattivo esempio, vagando per le strade con la barba”.
Ma sono tanti gli episodi, tutti significativi, che emergono dal racconto di Vera Bekteshi. Ad esempio quelli relativi al conformismo generale, basato sulla paura, che influenzava i rapporti tra le persone. Ad esempio, non appena fu arrestato il padre, la scrittrice, ancora studentessa, si vide invitata dalla direttrice della Biblioteca Nazionale a non frequentarla più perché “non ero ben gradita agli operatori scientifici con i quali studiavo nella stessa sala, la mia presenza li infastidiva”. E alla protesta della decisione da parte di Vera, la risposta della direttrice fu: “Non capisci che ora tu sei la figlia di un nemico del popolo?”.
Tanto nemica da essere costretta, come molti altri nelle sue condizioni, caduti sotto le maglie di quella che veniva chiamata “la scopa di ferro”, al “divorzio politico” dal marito, che non si oppose affatto, anzi; e che per fortuna le lasciò il figlio di un anno da portare con se, sicché anche questi, chiamato Artur, sarebbe cresciuto in condizioni di internamento (e non a caso, c’è un passo in cui la scrittrice ci informa che oggi egli vive e lavora all’estero, nel nord Europa, dove è emigrato).
“La villa con due porte”, al di là della testimonianza che rappresenta, merita di essere letto anche per la grande capacità di evocazione affidata a una scrittura che fa leva su diversi tasti emotivi, non esclusi quelli dell’ironia e della poesia. Insomma, un bel libro, che dimostra come si può dipingere l’inferno e, pur tuttavia, non perdere il paradiso dentro di noi, trasmettendoci il valore della speranza e degli affetti famigliari.