
Armeni in fuga dal Nagorno Karabakh - Foto A. Avetisyan/OBCT
La pulizia etnica ai danni della comunità armena del Nagorno Karabakh, perpetrata dall'Azerbaijan e culminata con la guerra lampo del settembre 2023, è stata analizzata da un gruppo di ong che ha prodotto un report dal titolo: “Perché non ci sono armeni in Karabakh?". Un'analisi
Il testo dell’”Accordo sulla pace e l’istituzione di relazioni interstatali tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica dell’Azerbaijan” non è ancora noto. Si sa che l’accordo è in 17 punti, e i due paesi dovranno firmarlo e poi ratificarlo.
Questo processo potrebbe essere non meno difficoltoso della stesura del testo, che non è stato accompagnato da un dibattito pubblico nei due paesi. Dibattito necessario per la riconciliazione, per la convivenza pacifica dei due popoli lungo i confini da delimitare e demarcare, e ancora di più in quello che fu il Nagorno Karabakh e che dal 2021 è la Regione Economica del Karabakh.
A metà marzo il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzonyan ha dichiarato : “Voglio dire molto direttamente che al momento non vedo le condizioni per gli armeni del Nagorno Karabakh per tornare nella loro patria, nelle loro case e per vivere in sicurezza. E, francamente, non vedo alcuno sforzo da parte dell'Azerbaijan per garantire queste condizioni.”
Dopo la prima guerra del Karabakh, nessun azero aveva fatto ritorno. Il Grande Ritorno, il re-insediamento degli azeri in Karabakh e nelle regioni limitrofe, è stato conseguenza della riconquista. Dopo la seconda guerra del Karabakh, nessun armeno ha fatto ritorno, e potrebbe non farlo come conseguenza del processo di pace. Due esodi forzosi e mutualmente escludenti.
Sul secondo esodo uno studio congiunto di numerose ONG ha prodotto un report che ricostruisce cosa è successo dal 2020 al 2023, intitolato significativamente “Perché non ci sono armeni in Karabakh? ”.
La risposta è che c’è stata una campagna di pulizia etnica perpetrata sistematicamente per tre anni, che ha portato l’intera popolazione a non considerare plausibile la proposta formale dell’Azerbaijan di rimanere sul territorio accettando la cittadinanza azera.
Il report divide il processo in tre fasi: dalla fine della guerra dei 44 giorni all’inizio del blocco, il blocco di quanto era rimasto del Karabakh, la riconquista finale e l’esodo conclusivo.
Dal cessate il fuoco al blocco (novembre 2020- novembre 2022)
Dopo il cessate il fuoco del 10 novembre 2020 le forze azere di stanza vicino alle comunità armene hanno intrapreso un’intimidazione sistematica della popolazione locale. Le sparatorie regolari hanno preso di mira aree residenziali, agricoltori e attrezzature agricole, soprattutto in villaggi come Mkhitarashen, Shosh e Taghavard. I civili sono stati minacciati tramite altoparlanti e sottoposti a intimidazioni psicologiche.
Numerosi resoconti confermano l’uccisione di agricoltori e civili armeni, anche in presenza di peacekeeper russi, come documentato in un episodio a Martakert. La presenza dei peacekeeper russi aveva alimentato speranze di tutela e di possibilità di ritorno, e dopo la guerra numerosi armeni sono rientrati in Karabakh contando sul supporto militare russo.
Il contingente si è rivelato ininfluente verso le misure adottate dall’Azerbaijan. Non sono stati una forza di deterrenza per prevenire gli attacchi delle forze azere, tra cui l'occupazione di Hin Tagher e Khtsaberd nel dicembre 2020, che ha causato morti e prigionieri militari. Quando è stata chiesta protezione, i peacekeeper russi hanno consigliato agli armeni di andarsene.
Nel 2022 gli attacchi si sono intensificati, portando all’occupazione di villaggi come Parukh, costringendo la popolazione ad evacuare.
Le interruzioni della fornitura di gas hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di vita, lasciando 120mila persone senza riscaldamento. Il silenzio del governo azero su questi episodi ripetuti con frequenza crescente suggerisce un’approvazione tacita.
Baku ha rafforzato questa realtà di esclusione attraverso una retorica revisionista e la cancellazione culturale. Il presidente Ilham Aliyev ha negato la presenza armena storica nel Nagorno Karabakh, sostenendo che le iscrizioni armene sulle antiche chiese erano falsificazioni. I monasteri di Spitak Khach e Dadivank sono stati riclassificati come chiese albanesi-udi. Cimiteri, ponti e siti culturali armeni sono stati demoliti.
Dal 2021 non è stato concesso ai giornalisti stranieri di entrare in Nagorno Karabakh, ottenendo così un controllo rigoroso della copertura mediatica della situazione.
Il blocco (dicembre 2022 – settembre 2023)
Nel dicembre 2022, Baku ha imposto un blocco di nove mesi sul corridoio di Lachin, tagliando fuori gli armeni rimasti nel Nagorno Karabakh. La crisi è iniziata con le proteste per le operazioni minerarie da parte di azeri in abiti civili.
Le forze di peacekeeping russe hanno riaperto brevemente la strada, ma questa è stata presto bloccata di nuovo dagli “attivisti ambientalisti” azeri, in seguito identificati come figure legate al governo. Nonostante il Nagorno Karabakh avesse sospeso le operazioni minerarie e richiesto la supervisione internazionale, il blocco è continuato.
Nell’aprile 2023, l’Azerbaijan ha sostituito i manifestanti con forze militari e ha installato un posto di blocco sul ponte di Hakari, rafforzando ulteriormente il controllo.
Il blocco ha creato una grave crisi umanitaria. In Karabakh poco alla volta è cominciato a mancare tutto. Alle forze di pace russe e alla Croce Rossa è stato occasionalmente consentito di consegnare aiuti e trasportare pazienti, ma le forniture erano insufficienti e spesso in ritardo.
Da giugno a settembre 2023, nessuna fornitura di cibo ha attraversato il posto di blocco azero, peggiorando la crisi. Il 90% degli alimenti proveniva dall’Armenia.
L’Azerbaijan ha interrotto le infrastrutture essenziali, tagliando le forniture di gas dall’Armenia nel dicembre 2022. Temporaneamente ripristinate, le forniture di gas sono state interrotte definitivamente nel marzo 2023.
L’elettricità è stata tagliata nel gennaio 2023, quando Baku ha bloccato le riparazioni di un cavo elettrico danneggiato, costringendo a fare affidamento sulle riserve in calo del bacino idrico di Sarsang.
Le autorità hanno imposto blackout a rotazione, inizialmente di quattro ore al giorno, in seguito estese a sei. Il 12 gennaio 2023, i cavi di comunicazione sono stati tagliati vicino a Shushi, ma l’accesso limitato è stato successivamente ripristinato dopo i negoziati.
Baku ha continuato il blocco in violazione della Dichiarazione trilaterale del 2020 e ha ignorato gli ordini della Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo volti a garantire un passaggio sicuro attraverso il Corridoio di Lachin.
Il blocco ha causato una grave crisi umanitaria per assenza di cibo, combustibile, medicine. Si sono registrati attacchi agli agricoltori per impedire la produzione alimentare locale, ed è stato limitato l'accesso all’irrigazione.
Al momento dell’attacco finale, la popolazione era stremata.
Atto finale (19 settembre 2023)
Baku ha lanciato la riconquista totale dell’area con un’operazione durata meno di 24 ore, e iniziata dopopranzo il 19 settembre.
Il report nota che: “Non è stato fornito alcun preavviso ai civili per evacuare o cercare riparo. Non sono state adottate misure precauzionali per ridurre al minimo le perdite di vite umane accidentali e la missione di accertamento dei fatti ha documentato numerosi incidenti di bombardamenti indiscriminati in tutto il Nagorno Karabakh, che hanno causato vittime, anche tra i bambini. Inoltre, tutte le potenziali vie di fuga sono state prese di mira e i veicoli civili sono stati attaccati direttamente, con conseguenti perdite di vite umane e feriti.”
La popolazione si è trovata con il corridoio di Lachin ancora bloccato, e solo dopo qualche giorno è stato possibile iniziare un’evacuazione che ha preso la forma di un esito drammatico. Una coda di 80 chilometri è costata la vita a 69 persone, morte lungo il tragitto a causa di sfinimento, fame, emergenze mediche.
Una tragica esplosione al deposito di carburante di Haykazov, preso d’assalto il 25 settembre da una folla in panico di rimanere bloccata in Karabakh, ha causato 220 vittime e ne ha ferite gravemente altre 290, molte con ustioni estese. Circa 20 persone risultano ancora disperse.
Almeno 23 funzionari armeni, personale militare e civili sono stati arrestati dalle forze azere, tra cui i quindici fra politici e militari ancora sotto processo.
Dopo l’ondata di rifugiati armeni dalla Siria, Yerevan si è trovata a fronteggiare questo gigantesco, drammatico esodo cui ha fatto fronte alla bene e meglio.
Messa di fronte a quanto successo negli anni 2020-2023, Baku un po' nega, un po' rimarca che è quanto è stato fatto agli azeri durante e dopo la prima guerra del Karabakh. L’astio azero non è stato placato dalla vittoria, e le ingiustizie passate vengono ripagate con la stessa moneta.
E' in corso un processo di firma di una pace, ma non una pacificazione. A un girone di astio, se ne è aggiunto un altro. Questo né scongiura una nuova guerra, né trasforma una possibile mancanza di combattimenti in una pace.
La strada verso la convivenza pacifica dei popoli separati – invece che uniti – da un attaccamento profondo e inamovibile al Karabakh – è ancora tutta in salita, ed è letteralmente piena di mine.
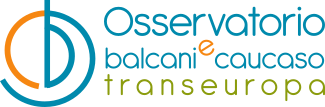





 To Top
To Top