
Bandiera della Jugoslavia © Shutterstock
"Per molto tempo quello jugoslavo è stato un esperimento importante, sotto vari aspetti, ma non può essere considerato un modello per diversi motivi. Ci sono però alcuni aspetti molto interessanti del progetto jugoslavo che non dovrebbero essere ignorati". Intervista col sociologo Paul Stubbs
(Originariamente pubblicato da Kosovo 2.0 , il 29 novembre 2022)
Alla fine di ottobre il sociologo Paul Stubbs ha tenuto una conferenza nella Biblioteca nazionale di Pristina dal titolo “La Jugoslavia socialista all’interno e al di fuori della colonialità: autogestione, autodeterminazione e non allineamento”. Al termine della conferenza, K 2.0 ha incontrato il sociologo per parlare del movimento dei non allineati e della sua eredità, dell’attivismo e delle politiche di sinistra nella regione ex jugoslava, nonché della necessità di un sistema di servizi sociali universali.
Alla fine degli anni Novanta la sua ricerca scientifica era focalizzata sulle politiche sociali globali, poi sul ruolo degli attori internazionali nel sud-est Europa. L’ultimo libro che lei ha curato si concentra invece sul ruolo della Jugoslavia socialista nel Movimento dei non allineati. Quindi, con il passare del tempo i suoi interessi di ricerca sono cambiati. Come mai?
Magari avessi una risposta precisa. Suppongo che il motivo sia semplicemente riconducibile ad una serie di scelte, circostanze e idee strane. Giunsi in Croazia nel 1993, in parte disilluso dal mio lavoro presso un’università del Regno Unito. Per qualche tempo lavorai in un campo per rifugiati, per poi decidere di intrecciare lavoro pratico, attivismo e ricerca.
Il mio percorso mi portò ad osservare cosa stava accadendo nello spazio post-jugoslavo così com’era allora e il ruolo che vi ebbero gli attori internazionali. Mi stavo avvicinando alle questioni legate alla globalizzazione principalmente da una prospettiva post-jugoslava, continuando, nel corso degli anni, ad occuparmi anche di politiche sociali.
In quel periodo scrissi diversi saggi dedicati ai movimenti nati negli Ottanta in Slovenia, ai punk rock e a movimenti sociali più ampi, evidenziando come questi movimenti rappresentassero una forma di resistenza contro un socialismo deterministico, per poi ritrovarsi schiacciati dai nazionalisti. I movimenti sociali sloveni si interessavano al Kosovo e a quanto stava accadendo alla popolazione albanese. Alcune persone che negli anni Ottanta in Slovenia erano impegnate in questo tipo di attivismo pacifista si erano recate in Kosovo, rimanendo sconcertate da quello che avevano visto, che sostanzialmente era uno stato di polizia.
Quindi, queste erano le riflessioni che mi frullavano in mente, ma anche l’idea di un progetto di sviluppo alternativo. Dissi a me stesso che un giorno mi sarei occupato del movimento dei non allineati. Inizialmente intendevo studiare il ruolo dei non allineati nella promozione dei diritti sociali riconosciuti dalle Nazioni Unite, quindi un argomento alquanto noioso, formale. Ma appena iniziai a studiare gli archivi, mi resi conto che c’erano in gioco cose molto più importanti: la tensione tra dinamiche interne ed esterne, il contrasto tra il non-allineamento dall’alto e quello dal basso e, soprattutto, il dilemma su come posizionarsi in Europa con un occhio rivolto al Sud globale. Tutte queste questioni mi parvero profondamente contraddittorie, ma al contempo incredibilmente interessanti e importanti non solo dal punto di vista storico, ma anche per quanto riguarda i dibattiti contemporanei e l’attivismo politico.
Nel corso della conferenza nella Biblioteca nazionale di Pristina, ha menzionato tre termini collegati tra loro: jugonostalgia, jugoamnesia e yugosplaining. Se il primo termine è ormai diventato parte integrante del discorso pubblico, lo stesso non si può dire degli altri due…
Si tratta di termini complessi e problematici. La jugoamnesia è una tendenza ben strutturata a dimenticarsi della Jugoslavia. Io tendo a riferirmi con questo termine alla Jugoslavia socialista, ma può essere utilizzato anche in relazione alla prima Jugoslavia. Quindi, una tendenza profondamente strutturata a cancellare la Jugoslavia dal discorso pubblico e politico. Ovviamente, il modo in cui Belgrado, o meglio la leadership politica serba ogni dieci anni strumentalizza il movimento dei non allineati, piegandolo a proprio vantaggio, è molto problematico, quindi a volte [le autorità serbe] cercano di abbinare l’amnesia alla nostalgia [per la Jugoslavia] per raggiungere i propri scopi.
La jugonostalgia invece, secondo me, è più che altro un concetto culturale. Ad esempio, a Lubiana ci sono diversi locali jugonostalgici. A provare questo sentimento sono soprattutto persone cresciute ascoltando la New Wave jugoslava. A loro non importava che la band Leb i sol venisse dalla Macedonia. Non importava nemmeno che gli Idoli fossero una band belgradese. È la musica della loro adolescenza e prima età adulta. Vi è anche una nuova generazione che sta riscoprendo questa musica.
La jugonostalgia però è diventata anche parte integrante di una specie di progetto politico che guarda alla Jugoslavia socialista come ad un possibile modello di socialismo. Per molto tempo quello jugoslavo è stato un esperimento importante, sotto vari aspetti, ma non può essere considerato un modello per diversi motivi, tra l’altro perché non c’è mai stato un socialismo jugoslavo unico ed omogeneo. Ci sono però alcuni aspetti molto interessanti del progetto jugoslavo che non dovrebbero essere ignorati.
Per quanto riguarda invece lo yugosplaining, è un concetto molto più recente, proposto da un gruppo di studiosi – tutti provenienti dalla regione ex-jugoslava, ma attualmente residenti all’estero – in risposta a quello che hanno percepito come sorta di eurosplaining, estendendo così le critiche mosse al mansplaining, ossia alla tendenza dei generi, orientamenti sessuali e culture dominanti, nonché delle forze egemoniche a imporre la propria concezione del mondo. Era un modo ironico per chiedere: perché non parliamo più spesso di Jugoslavia? Perché non ricominciamo a parlare di Jugoslavia all’interno della disciplina delle relazioni internazionali, ma anche all’interno della storia delle idee politiche?
Ben presto però anche gli stessi promotori di questa iniziativa si sono resi conto, grazie alle critiche avanzate dagli albanesi del Kosovo e della Macedonia del Nord, che anche il concetto di yugosplaining deve essere utilizzato con cautela, tenendo in considerazione il colonialismo interno e la violenza strutturale a cui furono sottoposti gli albanesi nella Jugoslavia socialista. Perché se c’è qualcosa che caratterizza in modo intrinseco il colonialismo, è la violenza.
Per quanto mi riguarda, nel mio lavoro cerco di evitare tutte le tendenze sopra descritte, quindi sia la jugoamnesia che la jugonostalgia, ma anche lo yugosplaining e un eccessivo jugocentrismo.
Alcuni studiosi tendono a leggere le realtà post-socialiste sotto una lente post-coloniale. Lei cosa pensa di questo approccio?
Tra gli studiosi che utilizzano questo approccio ci sono anche alcuni miei amici, quindi devo stare un po’ attento. Inizialmente anch’io ero attratto da questa prospettiva, perché andava di moda, ma poi si è rivelata tutt’altro che semplice. L’Unione Sovietica era un impero? Aveva soggiogato i paesi baltici allo stesso modo in cui il Regno Unito aveva soggiogato l’India? No, ma può essere utilizzata come una metafora ed è qui che iniziano i problemi. Una volta che si decide di ricorrere a metafore parlando dei “post” (post-colonialismo e post-socialismo), si finisce per impantanarsi in un groviglio, perché il concetto di postcoloniale viene talmente esteso da sfuggire a qualsiasi analisi scientifica. Dobbiamo sempre tenere a mente che quella che viene definita teoria post-coloniale in buona parte si basa su studi letterari.
Ciò che veramente mi interessava era evidenziare che bisognava andare oltre la teoria post-coloniale e osservare quello che stava effettivamente accadendo sia dal punto vista storico che empirico. Dobbiamo osservare quelle che io chiamo affinità decoloniali (decolonial affinities) e il loro carattere contraddittorio. Inoltre, dobbiamo parlare di capitalismo e di vari modelli di capitalismo. Dobbiamo parlare delle complessità e problematicità insite nel fenomeno della transizione. Di che tipo di transizione si è trattato e quali elementi del passato restano ancora vivi, come un repertorio di immagini, nelle pratiche, nelle istituzioni e nei ricordi delle persone?
Lei analizza la Jugoslavia socialista in un contesto imperniato sul concetto di colonialità. Cosa significa osservare la Jugoslavia socialista “all’interno e al di fuori della colonialità”, per citare le sue parole?
Credo sia stato Samir Amin, nelle sue opere dedicate al Sudafrica, a parlare del colonialismo interno. Quindi, abbiamo un grande stato-nazione, uno stato di apartheid, in cui è possibile riconoscere quelle che chiamiamo relazioni coloniali: da un lato ci sono i soggetti politici, dall’altro gli oggetti politici, ossia un gruppo di persone razzializzate e classificate come tali, e di conseguenza escluse dal potere politico, economico e sociale.
Queste dinamiche, a mio avviso, possono essere analizzate anche in relazione alla Jugoslavia socialista. L’esempio jugoslavo permette di capire come si può sviluppare una forma di colonialismo interno. Allo stesso tempo però, la Jugoslavia socialista ha giocato un ruolo importante nel movimento decoloniale attraverso gli atti di solidarietà con i movimenti di liberazione nazionale, ma anche partecipando al movimento dei non allineati.
Quindi, è qui che risiede una delle principali contraddizioni del movimento dei non allineati…
A me interessano molto le contraddizioni, l’idea di mettere a nudo le molteplici contraddizioni che rendono impossibile sviluppare un’unica narrazione attorno ai temi legati al movimento dei non allineati, temi che dieci anni fa non suscitavano molto interesse tra gli studiosi. Oggi invece ci sono molte persone, compresi giovani ricercatori, che hanno conseguito un dottorato di ricerca dedicato a questa problematica e continuano ad occuparsene portando avanti la propria carriera accademica.
Anche gli attivisti mostrano un certo interesse per il movimento dei non allineati. Quindi, mi sembra che questa questione stia assumendo una rilevanza sempre maggiore, oggi si studiano anche architettura, arte, musica e conoscenze popolari [dei paesi non allineati]. Esisteva anche una rete di agenzie di stampa dei non allineati. Viene dunque da chiedersi: com’era il giornalismo a quel tempo? Com’era la vita quotidiana? Come si svolgevano gli scambi universitari? Molti studenti del Sud globale venivano in Jugoslavia per proseguire gli studi, ma gli studenti jugoslavi non andavano nei paesi del Sud globale, ed è un peccato.
Uno dei concetti chiave alla base del movimento dei non allineati è quello di autodeterminazione. Attualmente in Kosovo al governo c’è Lëvizja Vetëvendosje [Movimento per l’autodeterminazione]. Lei ha avuto modo di seguire l’evoluzione del concetto di autodeterminazione così come è stato articolato dal movimento Vetëvendosje?
Purtroppo era dal 2007 che non venivo in Kosovo. All’epoca, mi sembrava che non ci fosse alcuna possibilità che emergesse una nuova forza democratica di sinistra. La possibilità evidentemente c’era, ma io non l’avevo intravista.
Non seguo molto questa questione, e mi sento in colpa per questo. Ma se lei dovesse pormi una domanda riguardante la situazione politica in Serbia, Macedonia o Montenegro, risponderei allo stesso modo, in parte perché mi sento davvero frustrato dal fatto che il dibattito su questi argomenti sia dominato da persone allineate al pensiero dei think tank liberali che osservano la regione [ex jugoslava] in un’ottica focalizzata esclusivamente sul processo di adesione all’Unione europea. Trovo queste dinamiche non solo profondamente problematiche, ma anche noiose.
Quando finalmente mi sono reso conto che in albanese “vetëvendosje” significa autodeterminazione e che quello di autodeterminazione è uno dei concetti chiave – secondo alcuni il concetto chiave – del movimento dei non allineati, mi è sembrata una questione su cui valeva la pena riflettere. Non credo che la scelta del nome del movimento Vetëvendosje fosse del tutto slegata dal movimento dei non allineati, o addirittura ignara della sua esistenza come un espediente che permettesse di costruire gli stati nazione in un contesto transnazionale.
Quello di autodeterminazione era uno dei concetti più importanti e, al contempo, più problematici nella Jugoslavia socialista, perché anche se i fautori dell’egemonia serba si fossero dimostrati disposti ad ammettere che il concetto di autodeterminazione in teoria era applicabile alle repubbliche [facenti parte della SFRJ], di certo non avrebbero detto che poteva essere applicato anche alle province autonome. Ad ogni modo, l’autonomia del Kosovo fu revocata [nel 1989]. Dobbiamo essere chiari e riconoscere la violenza insita nelle dinamiche di cui sopra.
Credo che sarebbe interessante indagare in modo più approfondito l’impatto dell’idea del non allineamento sulle varie generazioni di attivisti kosovari. Se non erro, Ibrahim Rugova fu un sostenitore dell’internazionalismo. Mostrava un interesse straordinario per i movimenti attivi al di fuori della regione, anche per i movimenti extra-europei, e al contempo si interessava molto anche allo strutturalismo francese.
Il panalbanismo, inteso come corrente di pensiero e orientamento politico-ideologico, è tanto diverso dal panafricanismo? Perché il panalbanismo suscita così tanta preoccupazione, come se fosse la cosa peggiore al mondo? Credo che la risposta vada ricercata in un insieme molto complesso di reazioni emotive legate al mito dell’Europa occidentale, vista come un paradiso della democrazia liberale e dello sviluppo.
Nel corso della conferenza, lei ha affermato che oggi si assiste ad un utilizzo eccessivo del termine “decoloniale”. Può approfondire questo punto?
La mia posizione sull’argomento continua a cambiare. Non voglio scartare definitivamente il termine decoloniale, ma non voglio nemmeno che diventi un termine troppo generico, un mero significante. Penso che anche il neoliberalismo sia ormai diventato un mero significante.
Credo che dovremmo pensare alla decolonialità come ad un insieme di pratiche. Quando parliamo del movimento dei non allineati, dobbiamo considerare il fatto che c’era una certa affinità con la lotta di liberazione antifascista nella Seconda guerra mondiale, un’affinità che in Kosovo era diversa – ne sono consapevole – ma comunque c’era. Riflettendo sugli effetti che questa affinità ebbe in quel preciso momento storico [relativo alla partecipazione della Jugoslavia socialista al movimento dei non allineati] (utilizzo il termine “momento” a ragion veduta perché, pur non essendosi trattato di un semplice momento, non possiamo parlare nemmeno di una vera e propria epoca dal punto di vista della conquista della sovranità degli stati postcoloniali che erano riusciti a liberarsi dal giogo coloniale), possiamo porci vari interrogativi.
Quel momento e quella affinità, seppur in contraddizione tra loro, si erano rivelati molto fruttuosi. Erano stati instaurati legami concreti. Penso ai legami tra Tito e il presidente senegalese Senghor, a quelli tra Vida Tomšič, attivista [jugoslava] per i diritti delle donne, e Sirimavo Bandaranaike, [la prima donna premier] dello Sri Lanka, ma anche ai legami tra movimenti femministi, artisti, operatori culturali, architetti, studenti. Non possiamo cancellare questi legami dalla storia, ma non dovremmo dare per scontato che fossero fondati sull’antirazzismo. Parliamo di legami profondamente contraddittori e complessi.
Nei Balcani l’eredità del socialismo è complessa e sembra che proprio in questa complessità risieda il motivo per cui, per molto tempo dopo la caduta del socialismo, portare avanti una politica di sinistra è stato tutt’altro che facile…
In questo periodo sto scrivendo un testo sulla sinistra croata dopo la proclamazione dell’indipendenza e mi sto rendendo conto che [in Croazia] negli anni Novanta chi era di sinistra taceva, o veniva messo a tacere e marginalizzato, oppure cercava di esprimere le proprie idee politiche nell’ambito culturale e attraverso le attività delle ong focalizzate sui diritti umani, compresi i diritti delle minoranze e delle persone LGBT. Chi era di sinistra non lo poteva dire apertamente. Con il passare del tempo le cose sono cambiate, si è tornati a leggere Marx e a organizzare dibattiti e seminari sul marxismo.
L’eredità è importante, ma è anche una lama a doppio taglio, considerando che la sociologia jugoslava non ha mai affrontato in modo adeguato la questione di classe, così come non ha mai affrontato le questioni economiche. [Nella Jugoslavia socialista] si leggevano solo le opere del giovane Marx, del Marx umanista focalizzato sulla teoria dell’alienazione, ma non anche quelle in cui Marx parla del feticismo delle merci e dello sfruttamento. Nessuno criticava l’economia jugoslava da un punto di vista neomarxista.
Ecco perché la sinistra che ora sta riemergendo si trova ad affrontare una vera sfida. E dove cerca l’ispirazione? Sono portato a pensare che la sinistra abbia iniziato a ispirarsi a quelli che sono diventati una specie di celebrità dell’intellettualismo di sinistra: David Harvey, Hardt e Negri, ma anche Slavoj Žižek. Non mi sembra un punto di partenza molto promettente.
Parlando della regione [ex jugoslava], ciò che è davvero importante è cercare di capire come nel socialismo di mercato la componente mercantile abbia preso il sopravvento su quella socialista e come la Lega dei comunisti della Jugoslavia sia diventata una realtà profondamente burocratizzata, tecnicistica e manageriale. Nonostante tutto ciò, c’era ancora spazio per alcune iniziative dal basso, che però di solito avevano una vita breve. Poi negli anni Ottanta in Kosovo c’era solo repressione, il caos regnava sovrano ovunque, con l’introduzione delle politiche di austerità e del neoliberismo. Sappiamo tutti com’è andata a finire.
La guerra in Ucraina sta avendo pesanti conseguenze economiche in Europa e nel resto del mondo. Cosa possono insegnarci le crisi globali intrecciate a cui assistiamo rispetto le politiche sociali?
Nancy Fraser ha scritto sulle crisi intrecciate. C’è il riscaldamento globale, la crisi ambientale, la crisi del sistema di cura, non solo nella nostra regione, ma anche nel resto d’Europa. La popolazione sta invecchiando, le persone vivono più a lungo, ma non vivono una vita più sana rispetto al passato. Poi è scoppiata la pandemia, e ora c’è la guerra in Ucraina. Quindi, abbiamo un insieme di crisi globali che hanno acuito le disuguaglianze già esistenti a livello globale e all’interno dei singoli paesi.
Queste crisi hanno anche portato all’emergere di un nuovo quadro geopolitico. Pur avendo gli Stati Uniti e l’Unione europea mantenuto una certa egemonia, non hanno il dominio totale. Dall’altra parte, la Russia, avendo perso la sua egemonia, sta portando avanti un vano tentativo di creare nuovamente un impero o un feudo, comunque lo si voglia chiamare. Poi c’è la Cina che gioca un ruolo importante, sia dal punto di vista diplomatico sia per quanto riguarda gli investimenti e la ‘Belt and Road Initiative’.
Questo quadro alquanto complesso richiede una nuova politica sociale transnazionale. Se lei e io ci spostiamo da un paese all’altro, perché non possiamo portarci dietro i nostri diritti sociali? Perché i diritti sociali non possono essere trasportabili? Perché devono essere basati sulla cittadinanza? Oltre che di un reddito di base universale, perché non possiamo discutere anche di servizi universali?
Uno degli aspetti negativi che mi hanno colpito qui in Kosovo è legato al fatto che, pur essendo le politiche sociali per certi versi evolute in modo positivo, non sono stati sviluppati nuovi servizi. Anche laddove esistono i servizi, sono riservati a chi può permetterseli. Per usufruire dei servizi universali devi aspettare in fila, oppure avere le conoscenze giuste. A volte gli standard sono estremamente bassi, perché i servizi riservati ai poveri tendono a trasformarsi in servizi scadenti.
La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo essere consapevoli dell’esistenza di una necropolitica: quando i servizi sanitari scarseggiano sono i potenti a decidere chi vive e chi muore. E per quanto riguarda la sanità, le gerarchie sono sempre complesse, conta l’età, ma contano anche le disabilità. È un fatto positivo che in Kosovo i bambini con disabilità gravi, che vivono a casa con la loro famiglia, possano usufruire di un assegno sociale. Ma se con i soldi ricevuti non possono permettersi servizi dignitosi, allora tale politica non ha alcun senso. Quindi mi piacerebbe che venisse creato un sistema di servizi sociali universali di qualità.
Ha seguito l’implementazione delle politiche sociali recentemente adottate in Kosovo, rivolte soprattutto alle donne e ai bambini? Cosa pensa di queste misure?
Mi ero occupato per la prima volta del Kosovo proprio dal punto di vista della politica sociale. Il governo britannico, in collaborazione con la Banca mondiale, si era impegnato a rafforzare la rete di centri di assistenza sociale [in Kosovo], pensando ad un possibile modello di servizi per il futuro. All’epoca avevo seguito attentamente questo processo. Ero rimasto sconcertato dal fatto che il sistema pensionistico, ideato da alcuni americani, fosse stato imperniato sui fondi pensionistici offshore in modo tale da non permettere ai politici al potere in Kosovo ad apportarvi alcuna modifica.
Ho seguito anche gli sviluppi successivi e penso che alcune misure adottate siano molto progressiste. Sono stato coinvolto anche in attività di lobbying con l’Unicef per l’introduzione dell’assegno familiare per i figli in Kosovo e Albania. Molti anni dopo in Kosovo è stato finalmente introdotto un assegno familiare, ed è un passo molto importante.
Per quanto riguarda la Jugoslavia socialista, in Macedonia e se non sbaglio anche in Kosovo c’era un programma razzista di assistenza all’infanzia. Gli assegni familiari venivano erogati solo per i primi due o tre figli. È risaputo che questa politica era legata ad una convinzione diffusa che gli albanesi avessero un tasso di natalità molto alto. Persone come Vida Tomšič e altri attivisti jugoslavi avevano portato avanti una campagna presso le Nazioni Unite contro la logica malthusiana, secondo cui le cause del sottosviluppo sono da ricercare nella tendenza a fare troppi figli. Ma queste stesse persone erano mai intervenute in un simile dibattito in Jugoslavia?
Pensa che il discorso malthusiano fosse diffuso anche nella Jugoslavia socialista?
Sì. Molti però non se ne erano accorti, anche se era evidente, seppur non sempre esplicito.
Questa questione sembra legata alla razzializzazione dell’etnia albanese in Jugoslavia…
Sì, perché la razza non è una caratteristica intrinseca all’essenza dell’uomo. La razzializzazione è un processo finalizzato alla costruzione di gerarchie sulla base delle caratteristiche attribuite. Non è che gli albanesi abbiano una carnagione più scura [rispetto ad altri popoli ex jugoslavi]. Parliamo di una categorizzazione profondamente razzializzata. Questa argomentazione è stata proposta da Piro Rexhepi.
Quindi, nella Jugoslavia socialista c’era un colonialismo interno, alcuni lo chiamano un sistema di apartheid, ma forse è un’esagerazione. Occorre però sottolineare che, se da un lato è vero che in ex Jugoslavia lo scontro tra le due versioni dello slavismo – quello croato e quello serbo – non è mai stato risolto, è altrettanto vero che anche la questione dei popoli non slavi, quindi gli albanesi e i rom, non è mai stata affrontata in modo adeguato.
La punizione di una classe subalterna, la costruzione di una classe subalterna, un’espulsione sistematica delle persone dall’amministrazione pubblica, questi i principali aspetti problematici della Jugoslavia socialista. Per questo credo che il popolo albanese sia stato razzializzato.
Dobbiamo però tenere a mente anche uno sviluppo diseguale. I dati che ho presentato dimostrano che nel 1989 la situazione [economica] in Kosovo era peggiore rispetto al 1949, testimoniando il fallimento di un progetto jugoslavo basato sulla modernizzazione e lo sviluppo.
Secondo lei, qual è l’eredità del movimento dei non allineati? Questo progetto ha ancora una rilevanza, soprattutto per quanto riguarda l’attivismo e l’internazionalismo progressista di oggi?
Percepito come una realtà istituzionale, il movimento dei non allineati non riveste più alcuna rilevanza, ma è ancora importante come simbolo di un’affinità decoloniale transnazionale e di un internazionalismo progressista non eurocentrico. Credo che l’idea di un ordine morale, di un sistema di valori che non si è disposti a sacrificare sull’altare della realpolitik sia molto importante. Se il Consiglio di sicurezza dell’Onu non avesse introdotto il diritto di veto, se ci fossimo sbarazzati definitivamente delle armi nucleari, se il diritto all’autodeterminazione fosse stato garantito a tutti i paesi e popoli, probabilmente non saremmo finiti nella situazione in cui ci troviamo oggi.
Questo è ovviamente un pensiero utopico, perché la politica è sempre realpolitik. Trovo però interessante il fatto che all’epoca della Jugoslavia socialista la tutela degli interessi nazionali e la ricerca di nuovi mercati non escludesse un’autentica solidarietà e volontà di comprendere cosa stava accadendo in Africa, andando oltre gli stereotipi razzializzati e razzisti. È stato solo un momento, non è durato abbastanza a lungo, non è stato articolato abbastanza, non ha interessato la vita quotidiana delle persone, ed eventuali effetti sulla quotidianità sono stati rapidamente cancellati.
Ho scritto un testo per l’Internazionale Progressista in cui sostengo che l’eredità [del movimento dei non allineati] non debba essere ricercata nella struttura istituzionale, bensì nelle richieste, nei discorsi e nelle rivendicazioni legate all’autodeterminazione e alla risoluzione pacifica dei conflitti. Queste istanze ci insegnano perché dobbiamo liberarci dalle armi nucleari, non si tratta solo della paura di essere distrutti. Se riuscissimo a liberarci dalle armi nucleari avremmo più soldi per i programmi sociali. Credo che si tratti di una questione di grande rilevanza per l’internazionalismo progressista del nostro tempo. Dobbiamo abbandonare la logica bipolare e sviluppare forme di solidarietà che guardino oltre l’Europa.
Dobbiamo riconnetterci con l’internazionalismo progressista, affrontare seriamente le questioni legate al colonialismo e al neocolonialismo e riflettere sulle lezioni che potremmo imparare dal mondo extraeuropeo.







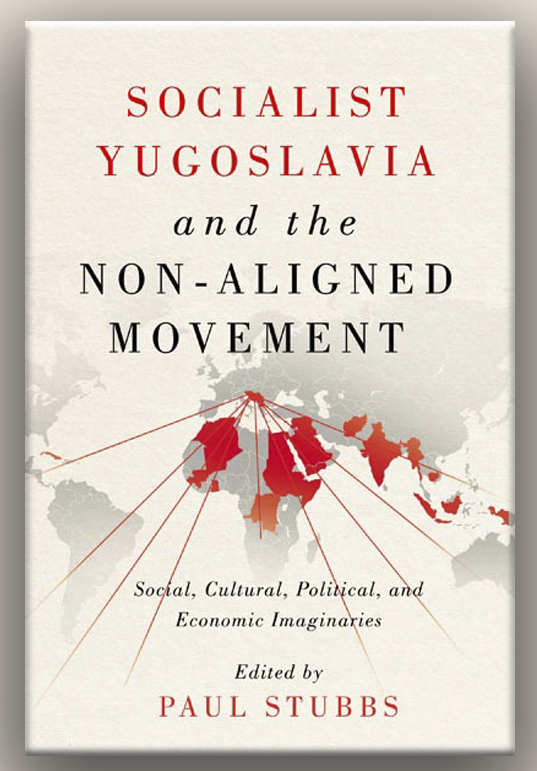
 To Top
To Top