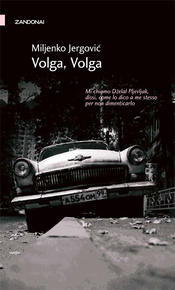Una Volga - Shutterstock.com
Non è uno sguardo nostalgico, e nemmeno di condanna quello con cui Miljenko Jergović guarda alla Jugoslavia di Tito. E' piuttosto una presa d'atto di ciò che è stato. Una recensione
Tra gli scrittori della ex Jugoslavia, il bosniaco, ma ormai croato di adozione, Miljenko Jergović è tra i più tradotti in Italia (e, sempre, pur nella diversità degli editori che finora l’hanno pubblicato, dalla mano felice di Ljiljana Avirović). L’ultimo libro, in ordine di tempo, è “Volga, Volga”, appena edito da Zandonai, un romanzo che, allontanatisi i tragici fatti dell’ultima guerra interetnica, fa i conti con gli anni del regime titoista, in un’ottica che non è certo quello della nostalgia, ma neppure della condanna. Piuttosto della presa d’atto di ciò che è stato: una registrazione di eventi a posteriori, dal timbro spesso ironico, che mette in luce come, nonostante tutti i tentativi di omologare le diverse componenti etniche, linguistiche e religiose che dovevano consolidare la ex Jugoslavia, in realtà il risultato non poteva essere che il fallimento. Troppa violenza, troppa corruzione, troppi tradimenti, troppi opportunismi.
L'autista
Jergović perviene a tutto ciò da par suo, attraverso la vicenda personale di Dželal Pljevljak, un autista civile dell’esercito jugoslavo che è proprietario di una Volga (da qui il titolo), un auto di fabbricazione russa, da lui acquistata di terza mano dal generale Musadik Karamuijć, al cui servizio è stato finché questi – e poi lo stesso Dželal - non è andato in pensione. Ed è appunto dai ricordi e pensieri che attraversano la mente di Dželal, mentre si trova al volante della sua Volga, che, in un gioco di spostamenti nel tempo e di epoche, la storia del romanzo si svolge, mescolando quella privata, triste, carica di una rassegnazione tutta religiosa, di Dželal e quella pubblica, feroce, della Jugoslavia. Dove è chiaro, naturalmente, che ciò che vale nel privato della vita di Dželal, ha valore simbolico, prismatico, della storia pubblica.
La storia di Dželal, nella sua essenza, è riassumibile in poche battute: nato nel 1933, o forse nel 1929, “nemmeno questo si sa con certezza”, da Abdulrahman, un gendarme reale in servizio provvisorio a Berane, e da Devla, fu subito oggetto di chiacchiere per il fatto che fosse nato dopo sei mesi di matrimonio, così contravvenendo a un precetto della religione musulmana a cui i genitori appartenevano.
Si appurò però che in effetti era nato prematuro, ma per la circostanza che fosse tutto peloso e con la coda, gli si diede subito del šejtan, cioè diavolo, finché la mamma riuscì a convincere la gente che si trattava di un miracolo divino, per il fatto che, pur nato di sei mesi, era sopravvissuto. Avrebbe avuto anche un fratello, Ragib, del quale si danno scarne notizie, mentre molto, per quanto non tutto, si sa di Dželal, da quando entrò nell’esercito nel 1951; così come si sa che qui si sarebbe ammalato di malaria e, ricoverato in ospedale, avrebbe trovato nella infermiera Mersiha la moglie che gli avrebbe dato una figlia, Maja. Questa, molto malaticcia, ma intelligentissima, sarebbe scomparsa misteriosamente verso i 14 anni di età (e attraverso la sua parabola passa molto dello spaccato del paese costruito, a cominciare dai ragazzi, nelle scuole, sulla mitologia di Tito). Di quella scomparsa, finita in archivio, pochi gli indizi: una popò dietro un cespuglio di more e un paio di mutandine trovate a duecento metri da lì. La madre, Mersiha, fu ricoverata in una casa di cura, Dželal, divenne uomo di fede, tant’è che, in pensione, con la sua vecchia Volga prese ad andare tutti i venerdì da Spalato, dove abitava, alla moschea di Livno, centosedici chilometri per pregare il suo dio. Però un giorno, gli scoppia una gomma, ed è costretto a fermarsi; chiede così aiuto a una casa lì vicino, scelta tra due che c’erano, solo perché sulla porta il cognome della famiglia era musulmano.
La Jugoslavia di Tito
Prenderà qui corpo un incontro che cambierà la vita di Dželal, al punto di fargli perdere la fede. Ma non è che il capitolo finale di un mondo, del quale Jergović ha disseminato per tutto il romanzo storie, episodi, molti dei quali legati a personaggi storici reali, che danno idea del prezzo, che nessuno era disposto a pagare, per avere una Jugoslavia così come la immaginava Tito. Perché, in realtà, era figlia dell’arbitrio di pochi eletti passati attraverso gli opportunismi del momento e, simbolicamente, rappresentati dalla figura, ben disegnata, di Osman Jusufspahić, già dell’OZNA e poi dell’UBDA, del quale sembrerebbe avrebbe scritto anche lo scrittore montenegrino Miodrag Bulatović (in Italia noto per un paio di romanzi di successo “Arrivano i demoni” e lo straordinario “Il gallo rosso”).
Di questa Jugoslavia sono testimonianza soprattutto i racconti del vecchio capofamiglia della casa in cui Dželal capita, un ex ladro di cavalli, truffatore, con dodici anni di galera alle spalle in Croazia e in Italia. Racconti che, come in un grande puzzle che si compone pagina dopo pagina, si collegano alle esperienze e ai ricordi stessi di Dželal. Ne cito solo uno perché dà idea della durezza dei tempi, quando lui, ancora in servizio, accompagnò con la Volga il suo generale Karamujić a un incontro con il colonnello Adolf Reš, quello che a suo tempo aveva detto “a Đilas che non era più Đilas”, e a Ranković, capo dei servizi segreti in disgrazia, mezz’ora prima che fosse destituito, di scegliere tra il suicidarsi “per rimanere nella memoria come eroe serbo, oppure vivere da pensionato a Dubrovnik, mentre l’esercito e il partito si sarebbero dati da fare affinché nessuno lo ricordasse come un eroe”.
Da citare anche un’altra sua frase (rivolta in questo caso ai nazionalisti croati): “Noi siamo in grado di arrestare anche i morti, se ciò dovesse risultare utile al Paese”. Un Paese che, però, abbiamo visto la fine che ha fatto, e a cui questo romanzo cerca di dare delle risposte.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Osservatorio Balcani e Caucaso and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The project's page: Tell Europe to Europe.