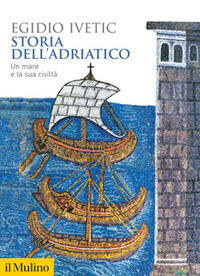Il mar Adriatico presso Zara - © Pul Kock Lee/Shutterstock
Non un normale saggio storico perché racchiude in sé la poesia della conoscenza e la qualità del libro di avventura. Una recensione di “Storia dell’Adriatico. Un mare e la sua civiltà” di Egidio Ivetic
Egidio Ivetic non è solo un ottimo storico e un accademico (docente di Storia moderna e Storia del Mediterraneo nell’Università di Padova) ma in gioventù ha fatto il marinaio di leva, come cittadino jugoslavo, sulla Galeb. Quello che sa dell’Adriatico orientale – ha recentemente affermato - l’ha imparato lì: nel gelido inverno 1984-85, a vent’anni, il nostro si trovava alle bocche di Cattaro, nello squero di Tivat, ad osservare quel mare Adriatico che negli anni futuri avrebbe definito come “spazio di contemplazione”.
“Storia dell’Adriatico. Un mare e la sua civiltà”, edito nel 2019 per la Società Editrice il Mulino, è sì una densa raccolta di informazioni dal 1000 a.c fino ai giorni nostri, che attraversa imperi, repubbliche e regni, ma non è un normale saggio storico perché racchiude in sé la poesia della conoscenza e le qualità del libro d’avventura.
La passione di Ivetic per l’Adriatico emerge in ogni pagina e non cede mai il passo alla noia o a bolse nozioni. Anzi, è un vero compendio, una sorta di antologia della conoscenza storico-marittima dell’Adriatico. Il filo conduttore lo conosciamo già, è quello tracciato da Braudel e da Matvejević, semplicemente Ivetic lo riannoda, ne fa un saldo nodo da marinaio e ce lo ripropone in una veste nuova, fresca, inesplorata.
Impressiona da subito la voluminosità delle note (60 pagine), con le fonti più disparate: dal manuale militare jugoslavo di “Tecnica e strategia di sbarco sulle coste italiane dell’Adriatico” (Zapadna obala Jadrana i Tarantski zavil, Split, 1968) alle commissioni ducali veneziane, dai manuali di storia di tutti i paesi rivieraschi agli atti notarili di entrambe le sponde.
Ivetic lo afferma molto chiaramente “nel Mediterraneo c’è un ulteriore mare che lo riassume. L’Adriatico è il Mediterraneo del Mediterraneo, è il corridoio marittimo che ha unito l’Oriente con l’Occidente per oltre un millennio”: mille anni di Venezia (ducato, comune e repubblica), 850 anni del Sacro romano impero, 816 anni di regno d’Ungheria e di Croazia, 542 anni di Asburgo, 443 anni di Impero Ottomano, 400 anni di repubblica di Ragusa, 150 anni di Italia unita, 73 anni di Jugoslavia.
Un Adriatico delle diversità, un mare confine, una “pianura liquida”, un “mare boreale, superiore” e, in definitiva, “un’area di diversità”. In ogni parola che Ivetic utilizza per descriverlo, troviamo una sorta di magnetismo verso il potenziale poetico del mare, verso la sua innata forza narrativa.
Grandissima importanza riveste il tema delle identità, affrontato con grande coraggio. Scopriamo ad esempio che durante la Serenissima la questione dell’identità aveva un significato secondario rispetto alle necessità della vita economica e che lungo la costa era diffuso il bilinguismo. Quindi fu proprio “lungo l’antemurale dalmata che si era sviluppato un mondo latino, italiano e croato, mentre nell’interno della provincia si erano situate popolazioni di fede ortodossa serba”. Siamo di fronte a secoli di convivenza linguistica e culturale, al giorno d’oggi un miraggio nel deserto.
Come si evince, buona parte del libro è dedicata, giustamente, a Venezia, la Dominante, che trasformò l’Adriatico nel suo Golfo, ne fece il suo “mare vettore”, un sistema di scambi e di commerci trasversali alla regione balcanica, tra Oriente e Occidente; un “mare integrato” incentrato sulla grandezza economica, politica e marittima di Venezia.
Il tracollo della Serenissima fu rapido e fu il primo di quelli che Ivetic chiama “sfaceli adriatici”: l’Austria-Ungheria nel novembre 1918, la prima Jugoslavia nell’aprile 1941, l’Italia fascista nel settembre 1943 e infine la seconda Jugoslavia nell’estate 1991.
Ed è proprio dalla caduta di Venezia nel 1797 che secondo il nostro inizia quello che definisce un “lungo Ottocento” che termina nel novembre 1918 con il tramonto dell’Austria-Ungheria. Questo periodo ha visto trasformarsi l’Adriatico “da luogo in geografia: l’azione dell’uomo puntava a ridefinire il territorio litoraneo […] Non più comunità sparse lungo la costa, ma il litorale inteso come una frontiera che andava difesa dallo stato, studiata dagli scienziati, interpretata dai viaggiatori come un tema narrativo”. Ed è in questo momento che si apre una frattura nella convivenza tra i popoli adriatici, è proprio in questo periodo che “tra geografi civili e militari, matura la mitologia del confine naturale dello stato nazionale: l’estrema Italia era un arcipelago che si snodava da Trieste a Zara, con i suoi dialetti veneti, la sua storia e cultura, le navi, le industrie, la cucina, le tradizioni. Questa estrema Italia era anche l’estrema Slavia, lì attaccata”.
Il “confine orientale” italiano divenne quindi “un vero e proprio mito, il coronamento del risorgimento nazionale, la prova della forza e della maturità della nazione. In più c’era la mistica del confine geografico, dello spartiacque, del monte Nevoso”.
È in questo contesto che si affaccia un nuovo mare, la modernità marittima divenne di dominio mittelleuropeo, Trieste e Fiume ne rappresentarono la potenza economica e culturale. Trieste toccò i 240mila abitanti nel 1913 (quarta città dell’Austria Ungheria dopo Vienna, Budapest e Praga), la comunità slovena ne contava 50mila, più della stessa Lubiana. Se fosse stata attribuita alla Jugoslava sarebbe stata la seconda città, dopo Belgrado. Ivetic la definisce, in modo sognante, una “Marsiglia Jugoslava”, mai definizione fu più azzeccata.. Fiume invece è stata una “sezione metropolitana di Budapest”, qui “l’Europa danubiana si avvicinò al Mediterraneo”. Nel 1910 la popolazione che si professava di lingua italiana era il 48%, di lingua croata il 26%, la componente ungherese il 13%, seguivano le comunità tedesche, slovene, serbe, slovacche, ceche rumene, rutene, polacche e inglesi. La presa della città da parte di D’Annunzio nel settembre 1919 “fu la compensazione, cercata ancora una volta nel Quarnero, per le frustrazioni subite durante il primo conflitto mondiale. Fiume fu, come Zara, l’Italia estrema.”
Ivetic, grazie anche a una grande capacità di scrittura e alla precisione dei dati numerici che fornisce, ci fa sognare epoche che avremmo voluto vivere, ci fa entrare nella storia calandoci perfettamente nel fermento culturale delle città costiere, nelle geografie del territorio, respirando le ariose parlate cosmopolite o facendoci soffocare di rabbia per le nefaste vicende nazionaliste che si sono susseguite.
L’occupazione italiana delle coste adriatiche fu vissuta in Italia come la “prova della vittoria”, ma per la controparte “fu una prevaricazione rispetto alla situazione civile e politica prima del 1918, anche perché a parte Zara, negli altri centri della Dalmazia governavano da tempo i croati”. Quello italiano “fu un atteggiamento padronale, come se in virtù della vittoria fosse tutto dovuto. E a ciò va aggiunto un sentimento di superiorità dell’italianità, come cultura, lingua, civiltà”.
Adriatico, quindi, anche come mare della sofferenza e del dolore (quale mare, del resto, non lo è?), è il mare del campo di concentramento di Arbe, della risiera di San Saba e dell’esodo degli italiani. Ivetic afferma che, “a seconda delle interpretazioni si parla di 250.000 a 350.000 persone”, istriane, fiumane e dalmate che abbandonarono la loro terra natia.
A voler parlare di storia culturale dell’Adriatico, dice il nostro, “si potrebbe ragionare in termini postcoloniali, riconoscendo nel passato una cultura dominante e una cultura dei sottomessi o marginali”. Il rapporto tra l’Italia e l’Adriatico orientale “non sarebbe diverso da quello che c’era tra le metropoli e le loro colonie, come tra la Francia e il Maghreb”. Affermazione, quest’ultima, che rende bene l’idea del dominio coloniale italiano.
La Jugoslavia socialista divenne poi un (o il) paese novecentesco, più adriatico di quello che si pensi, in cui era contemplato un Adriatico jugoslavo e una mediterraneità jugoslava: “Si era slavi ma affratellati con i popoli latini nella condivisione del Mediterraneo”.
Infine, ragionare sull’Adriatico significa per Ivetic, “fare i conti con il suo essere un confine. Ogni pensiero adriatico, ogni ricerca sulle sue identità, diventa un pensiero di confine. E la posizione di confine comporta rischi grandi, di non essere né l’uno né l’altro, di essere periferia di entrambi i mondi che vogliono congiungere”.