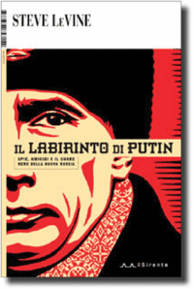(buttersweet - Flickr)
Pochi giorni dopo la morte di Litvinenko, ex agente dell’intelligence russa, LeVine comincia a scrivere un libro sulle morti sospette in Russia. Una storia densa di suspense come una spy story, ricca di protagonisti come un romanzo russo, tragicamente vera
“Poco prima della mezzanotte del 1 novembre 2006, Alexander Litvinenko, un ex agente dell’intelligence russa che viveva in esilio politico a Londra, si svegliò che stava proprio male. Nel giro di qualche giorno, una spaventosa fotografia del suo corpo emaciato in un letto d’ospedale scioccò il mondo. Tre settimane più tardi era deceduto per avvelenamento da polonio-210, un isotopo radioattivo che secondo gli investigatori era stato versato di nascosto in una bevanda”.
"Il labirinto di Putin", secondo libro di Steve LeVine dopo l’eccellente "Il Petrolio e la Gloria", nasce da un’idea di Will Murphy, editore della Random House. Un paio di settimane dopo la tragica scomparsa di Litvinenko, Murphy chiama LeVine chiedendogli se fosse interessato a scrivere un libro sulla morte dell’ex agente russo, oppositore di Putin.
LeVine, dopo essersi consultato con Noel Greedwood, ex direttore del Los Angeles Times, che gli aveva fornito preziosi consigli per la stesura del suo primo lavoro, decide di accettare l’offerta.
Il progetto originario suggerito da Murphy si trasforma però in qualcosa di più ambizioso e interessante come spiega lo stesso autore nelle pagine introduttive.
“Questo è un libro sulla morte in Russia. È nota al mondo la lunga storia russa di governanti feroci e di assassini spietati. Ma tuttora, nel primo decennio del ventunesimo secolo, la brutalità e la morte violenta sono di così ordinaria amministrazione da essere solitamente ignorate da tutti tranne dalle stesse vittime, le loro famiglie e i loro amici”.
Il giornalista statunitense sottolinea poi come “dopo sedici anni di vita e viaggi nell’ex Unione Sovietica” sia “arrivato alla conclusione che l’acquiescenza della Russia a questo cruento stato di cose la distingue da altre nazioni che si definiscono civilizzate. Capisco che è un giudizio duro, ma posso solo dire che non è affrettato”.
Il giudizio di LeVine, giunto per la prima volta a Mosca nel 1994 per raccontare in qualità di corrispondente dal Caucaso ciò che si agitava nei territori a margine dell’Impero russo – Georgia, Armenia, Asia Centrale, Cecenia e Inguscezia – è infatti il risultato di un’analisi ponderata, frutto di un lavoro di ricerca condotto utilizzando una pluralità di fonti (interviste, libri, articoli) come si evince chiaramente dalla bibliografia.
“Residenti stranieri e una minoranza scontenta di russi dicevano che il Paese interferiva oltre i propri confini provocando guerre nel Caucaso, bloccando accordi sul petrolio e oleodotti in Asia Centrale e operando in genere per preservare l’influenza di Mosca nelle repubbliche vicine che erano state parte dell’Unione Sovietica. Dapprima queste critiche sembravano infondate; sì, la Russia stava cercando di reinventarsi e forse di arricchirsi, ma non stava tentando di ricostituire un impero. Sarei stato presto smentito su questo punto di vista troppo benevolo”.
I frequenti viaggi nella martoriata Cecenia dove LeVine, per conto di Washington Post e Newsweek, assiste all’assedio di Grozny durante la prima guerra, accorgendosi che “i corrispondenti occidentali non erano considerati necessariamente dai militari russi come non combattenti neutrali” sono il primo campanello d’allarme.
Con la fine del primo conflitto ceceno, nel corso del quale LeVine prende coscienza che le truppe russe “non stavano solo tentando di reprimere una ribellione” ma “stavano uccidendo, attaccando e brutalizzando chiunque si trovasse sul suolo ceceno”, le immagini che lo avevano portato “a vedere i russi come insensibili alla vita della maggior parte degli altri” scivolano via dalla sua mente per qualche tempo.
È solo con la tragedia del sottomarino nucleare Kursk, affondato nelle acque ghiacciate del mare di Barents nel 2000, e con l’avvento al potere di Putin che LeVine incomincia ad interrogarsi sul corso della nuova Russia e a ricomporre i tasselli di un mosaico davvero inquietante.
Denso di suspense come una spy story, ricco di protagonisti come un romanzo russo – il cast annovera tra gli altri l’oligarca esule in Gran Bretagna Boris Berezovsky e Anna Politkovskaya, la giornalista di Novaya Gazeta, famosa per i suoi feroci articoli contro il Cremlino – il labirinto di Putin, reportage dall’andamento circolare (inizio ed epilogo hanno come sfondo la vicenda Litvinenko), si snoda lungo dieci capitoli che tengono il lettore incollato alle pagine grazie a una prosa secca e avvincente degna di un noir.
Tra i capitoli più interessanti, a parer di chi scrive, quelli dedicati allo scontro tra guerriglieri ceceni e autorità russe (Nord-Ost) e alla figura di Anna Politkovskaya, ritratta senza alcuna retorica (Omicidio in ascensore).
Le pagine che raccontano la vicenda del teatro Dubrovka di Mosca, dove nel 2002 militanti ceceni presero in ostaggio varie centinaia di spettatori sono sicuramente tra le più agghiaccianti. E tra le più emblematiche del nuovo corso voluto da Vladimir Putin.
Rifiutato ogni tentativo di negoziazione – Abu Bakar, il vice del leader ceceno Barayev, attraverso la mediazione di Anna Politkovskaya, aveva chiesto a Putin, quale condizione per il rilascio degli ostaggi, la cessazione del conflitto nella martoriata repubblica caucasica – le truppe speciali entrano in azione. Prima pompano all’interno del teatro il fentanyl, un gas oppiaceo, poi fatta irruzione sparano a morte contro i terroristi. Ma dimenticano di predisporre la liberazione degli ostaggi: 129 persone muoiono per mancanza di assistenza sulle loro poltrone, sui marciapiedi all’esterno e sugli autobus diretti agli ospedali.
“Tra i sopravvissuti e i loro parenti si sollevò un coro di critiche. Perché il Cremlino non aveva dato più di una possibilità ai negoziati? Cosa era accaduto a Viktor Kazantsev, il generale russo che presumibilmente stava tentando di negoziare un accordo?”
Yuri Sinelshchikov, un ex procuratore della città di Mosca, intervistato da LeVine, che si occupò dell’indagine relativa alla vicenda del teatro Dubrovka, sostiene che non ci fu alcun impegno da parte delle autorità per accertare la verità.
“Testimoni importanti non furono intervistati subito, ma due o tre settimane dopo. Alcune prove scomparvero. […] Le persone non furono sentite in dettaglio nel corso degli interrogatori. Se qualcuno era sospettato e doveva esser seguito segretamente, non lo si faceva per niente a dovere, ed era ovvio. Nei primi dieci giorni c’era il caos, e c’erano troppe persone coinvolte ad alto livello”.
Ancora oggi, come ricorda l’autore nella postfazione all’edizione italiana, scritta nel luglio 2010, a distanza di 8 anni dalla vicenda del teatro Dubrovka e di 4 anni dagli omicidi di Politkovskaya e Litvinenko nessuno ha individuato i responsabili di questi fatti di sangue.
Il 15 luglio 2010, in occasione del primo anniversario dell’omicidio di Natalia Estemirova, l’attivista di diritti umani che, per conto di Memorial, conduceva inchieste e ricerche sui crimini di stato in Cecenia, la promessa del presidente Dmitry Medvedev fatta l’anno prima di individuare i mandanti di quella barbara uccisione si era dissolta in una bolla di sapone.
“Medvedev aveva fatto entrambe le sue esternazioni, le condoglianze immediatamente dopo la morte della Estemirova e la relazione sui progressi delle indagini un anno dopo, in presenza del leader tedesco Angela Merkel, che aveva preso l’abitudine di puntare il dito verso il Cremlino in segno di rimprovero per le violazioni dei diritti umani”.
“L’operato di Medvedev – conclude amaramente LeVine – era di parlare con voce liberale di fronte agli occidentali”. Ma “c’erano scarse prove di un cambiamento concreto”. Nessun colpevole era stato identificato e “l’industria dell’omicidio agiva ancora impunemente”.