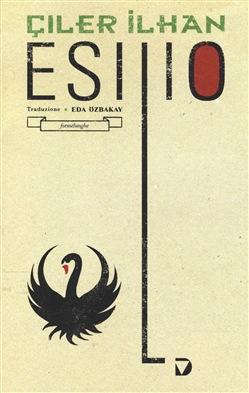"Esilio", il libro della scrittrice turca Çiler Ilhan, è fatto di "racconti tutti brevi e molto belli. Forti, nel senso che rivelano una tempra di scrittrice che la scrittura bene esprime. E qui va naturalmente ribadito il grande merito della traduttrice". Recensione
A leggere “Esilio”, il libro di racconti della scrittrice turca Çiler Ilhan, edito in Italia da Delvecchio editore e che ha vinto, tra l’altro, l’European Prize Literature 2011, si fa fatica a pensare che l’autrice sia perfettamente integrata nella società turca. Si penserebbe piuttosto a una ribelle che non a una manager delle pubbliche relazioni al Çarağan Palace Kempiski di Istanbul e con un passato di studi di altissimo livello all’Università del Bosforo e tirocinio in Svizzera.
Sì, perché questi racconti, pregiatamente tradotti da Eda Özbakav, stando alla forza che è riuscita a imprimere alla pagina in lingua italiana, raccontano di una donna che non fa sconti, soprattutto alla società maschilista turca, nei confronti della quale è molto, molto sferzante.
I racconti sono per lo più interpretazioni, da parte dell’autrice, di stati d’animo immaginati in personaggi di cronaca reali. Uno per tutti: si ricorderà Pippa, l’italiana che, come espressione artistica, girava a piedi per il mondo vestita da sposa e che un brutto giorno fu violentata e uccisa da un camionista turco? La polizia turca ne trovò il cadavere dodici giorni dopo che il camionista l’aveva strangolata. Ebbene la Ilhan si mette nei panni della madre.
Deve aver fatto delle ricerche per essere così sicuramente severa. Perché quella che parla è una madre cinica, che, rimasta incinta di Pippa, non la voleva e che a 32 giorni di vita aveva addirittura tentato di soffocarla con il cuscino per far credere che fosse morta rigirandosi, una madre che non ne voleva sapere di lei, così che poi ad accudirla in realtà sarebbe stata la sorella maggiore. Una figlia Pippa, secondo lei, cresciuta strana, per cui la fine che ha fatto non l’ha meravigliata. “Diceva che era arte ciò che faceva, insieme a un’amica volevano cucirsi dei vestiti da sposa e diffondere un messaggio di pace girando con l’autostop”. E il fatto che pochi giorni prima avesse telefonato a casa chiedendo che, se dovesse morire, la sua bara fosse portata dalle sue quattro sorelle, la madre lo prese come un’altra forma di esibizione. “Persino nell’andarsene cercava la fama”.
Una durezza di giudizio da parte di Çiler Ilhan che si ripeterà in tutti i racconti in cui le donne sono vittime. Un altro esempio di cronaca è il noto tasso altissimo di suicidi – in realtà omicidi – che avvengono a Bati Raman, sopranominata Batman, nell’Anatolia Sudorientale, dei quali si è più di una volta parlato. Uno dei primi racconti di “Esilio” – che poi, sì, sono tutti racconti di esilio, ma dalla vita, dalla ragione, dalla verità, in un mondo che affonda nell’ipocrisia, nel falso perbenismo, in tradizioni feroci dure a scomparire – uno dei primi racconti è proprio intitolato “Batman”. Cito solo una frase per far capire il senso di cosa succede lì: “Gli occhi dei nostri padri, stufi delle nostre madri, con i loro seni che pendono dopo il decimo parto, e con le carni afflosciate, si fissano sui nostri seni che stanno spuntando. Improvvisamente nostra madre diventa cieca, e i nostri fratelli sordi”.
Terribile. E scorrendo via via i racconti, in cui la scrittrice schiaffeggia un mondo intollerante e intollerabile, ecco ritornare più di una volta a Batman, allo stesso emblematico omicidio di una ragazza da parte dei suoi fratelli, per ordine del padre. E a parlare prima è la madre che nasconde a se stessa prima di tutto il fatto che a uccidere la figlia siano stati i fratelli; poi il padre, con ipocrita ignominia, che parla della figlia come di una svergognata, poi il minore dei quattro fratelli, che testimonia un’innocenza nutrita anch’essa di ipocrisia.
Oltre a personaggi comuni la scrittrice però non esita a indossare i panni di personaggi famosi della politica. In più di un racconto ad esempio c’è l’Iraq di Saddam. L’autrice non fa discorsi politici ne emette giudizi di questo tipo. Guarda, come sempre, agli uomini. E nel primo racconto eccola diventare una delle figlie di Saddam. Sia lei che la sorella sposarono due fratelli “naturalmente costrette da nostro padre”, i quali comunque erano delle brave persone, per cui “eravamo felici quanto lo potevamo essere”. Non proprio in sintonia con Saddam, furono costretti tutti all’esilio, non potendo neppure contare sui propri potenti fratelli, i figli preferiti di Saddam, Uday e Kusay, sadici e perversi. Sadici come il padre che finse un’amnistia, convinse le figlie a tornare in patria con i mariti e, tornati, invece, fece uccidere questi ultimi.
“Eravamo stati proprio ingenui…” è il triste commento della figlia. Peggio, perché il loro padre le fece assistere alla morte dei loro mariti. “Come se nostro padre avesse un cuore capace di arrabbiarsi o perdonare, come se avesse un grammo di coscienza, ci siamo attaccate a delle parole illusorie. Che Dio lo maledica.” Non finisce qui. Oh, sì, l’autrice si è davvero documentata su ogni fatto che racconta, per poi dare voce al personaggio che più esprime la tragica prospettiva, il quadro e l’ambiente, in cui quei fatti sono maturati. L’ultima riga del racconto su Saddam è la più liquidatoria di quella figura, quando il personaggio della figlia racconta il suo arresto - avvenuto dietro indicazione della figlia stessa del nascondiglio a chi gli dava la caccia - e la sua condanna a morte. Tutti, in risposta, le dicono: vedrai però con quale coraggio il comandante affronta il patibolo. “Favole. Tutte favole” commenta il personaggio figlia “Quel comandante al quale avevo detto dove si trovava mi è testimone: è morto supplicando”.
Racconti tutti brevi e molto belli. Forti, nel senso che rivelano una tempra di scrittrice che la scrittura bene esprime. E qui va naturalmente ribadito il grande merito della traduttrice.