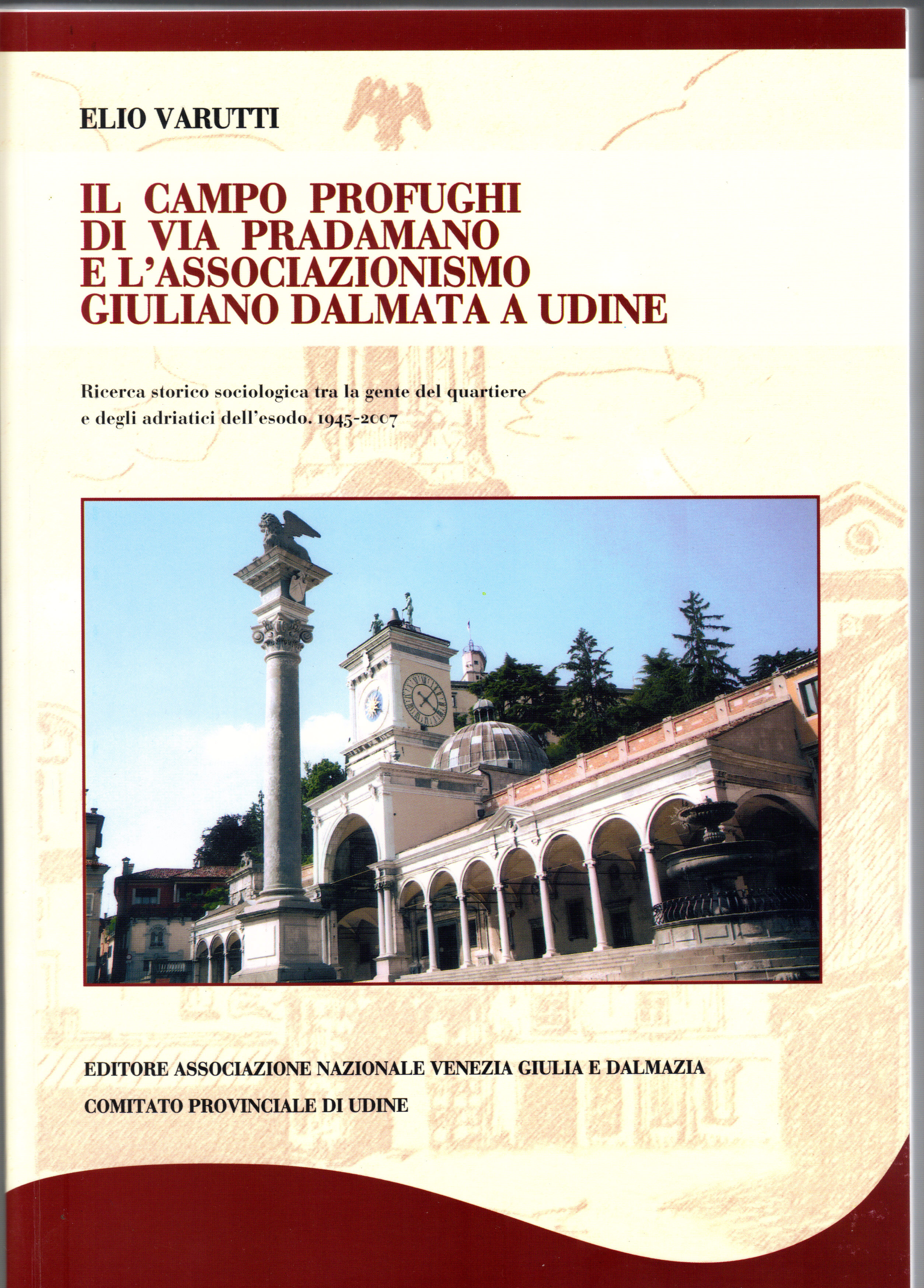
Un'intervista a Elio Varutti, storico e giornalista udinese, autore della prima indagine documentata sui centri di smistamento profughi aperti a Udine per accogliere gli esuli istriani, fiumani e dalmati tra 1947 e 1960
Il suo studio si incentra attorno a un luogo simbolico del confine orientale: il Centro Smistamento Profughi di via Pradamano a Udine, il più importante centro di prima accoglienza per gli esuli italiani, sorto all'interno di un edificio progettato dal fascismo, occupato dai tedeschi, poi bombardato dagli angloamericani, e che è attualmente sede di una scuola media statale, una biblioteca di quartiere e una piscina comunale.
Il campo profughi di via Pradamano 21 fu un fenomenale snodo di storia. Nessuno fra gli udinesi che ne avevano ricordo si immaginava che vi fossero passati 100.000 esuli tra 1947 e 1960. I racconti parlavano di alcune centinaia di persone, al massimo mille nei momenti di piena. Il fatto è che la loro permanenza a Udine generalmente era provvisoria: dichiarati al loro arrivo displaced persons, venivano accreditati come profughi, per essere mandati dopo 4 mesi in uno dei 109 campi profughi sparsi in tutta Italia. Relativamente pochi di essi si stabilirono qui in modo definitivo.
Del resto, in Friuli il flusso dei profughi da est fu continuo: cominciarono ad arrivare nel periodo tra le due guerre mondiali, in seguito a diverse forme di sfollamento delle zone di frontiera considerate a rischio: erano evacuazioni preparate dalle autorità militari del Regno d'Italia o spostamenti spontanei. Dopo la guerra, i provenienti dalle terre ex italiane affluirono in 6 diverse ondate. L'ultima corrisponde agli anni successivi al 1963, quando la Federativa Repubblica Jugoslava introdusse l'autogestione e i primi lavoratori a essere allontanati dalle strutture pubbliche furono proprio gli italiani: per questi fuoriusciti l'inserimento nella nostra regione risultò doppiamente difficile. Vennero espulsi dalla Jugoslavia dopo che i loro figli avevano imparato il croato a scuola e marciato con il fazzoletto rosso attorno al collo. Gli esuli già trapiantati a Udine li accusarono di legami con i comunisti di Tito e non li accettarono.
La sua indagine si compone di parecchio materiale inedito e il risultato è la ricostruzione di fatti storici finora mai messi per iscritto. In che misura possono delle frammentate testimonianze orali incidere sulla storiografia ufficiale facendo luce su eventi ancora oscuri?
Il mio è un contributo di microstoria: gli storici hanno sempre molte perplessità sulle fonti orali, che devono essere controllate. I sopravvissuti ai fatti narrano a ruota libera, a volte mescolando i tempi, altre volte facendo confusione tra i propri ricordi. Alcuni intervistati sono morti prima che uscisse il libro... Per verificare le testimonianze ho cercato riscontri tra documenti scritti, archivi pubblici e collezioni private, ma è stato comunque come mettere insieme le tessere di un mosaico molto variopinto. Per rispettare l'autenticità delle testimonianze, ho voluto trascrivere le interviste in lingua originale: l'istroveneto, il triestino, il dialetto della valle dell'Isonzo, il friulano. Ne è uscito un capitolo di storia dimenticata. Quasi non esistono fotografie dei luoghi, né disegni. Del campo profughi di via Gorizia, una baraccopoli di lamiera conosciuta come "il villaggio di ferro" che funse da centro di accoglienza a Udine prima ancora del campo di via Pradamano, non si saprebbe nulla se non ce ne parlasse la memoria popolare, che sta scomparendo ormai, assieme ai suoi protagonisti. La curiosità è che adesso, a libro stampato, emergono nuove storie, si fanno avanti altre voci. Oltre alle 103 interviste pubblicate, ne ho raccolte in seguito altre 18.
Lei ha parlato di accoglienza ambivalente dei friulani nei confronti dei fratelli d'Italia fuggiti da est. Appartiene alla sua storia personale, di bambino che giocava con i figli degli esuli, il ricordo della famigerata minaccia delle mamme del quartiere ai propri figli disobbedienti: "Stai buono, altrimenti ti faccio mangiare dai profughi!".
Nella zona di via Pradamano convivevano due ceti sociali: gli impiegati nel settore pubblico che abitavano le case popolari, e le famiglie che mantenevano invece le loro origini rurali. I profughi instaurarono un legame con la gente più semplice e non si vergognavano di andare a portare le bucce di patate ai contadini, che le davano in pasto ai propri maiali apprezzando questo gesto: "Ci sentivamo uguali", affermano. Tra gli udinesi, c'é chi ogni domenica assisteva alla messa nella cappella del Centro Profughi e oggi rammenta: "Abbiamo imparato tanti bei canti di fiumani e istriani!". I preti di diverse parrocchie udinesi si dedicarono interamente all'opera di accoglienza: la Chiesa del Carmine, che era il covo degli incontri segreti dei partigiani di Osoppo, divenne contemporaneamente anche la sede delle riunioni degli esuli.
Nel resto della città, però, la struttura di via Pradamano non godeva di buona fama, per via degli episodi di accoltellamenti fra croati e serbi, anch'essi ospiti del campo: si trattava di clandestini, fuggiti dalla Jugoslavia per renitenza alla leva. Pur minoritari, questi gruppi organizzarono perfino una rivolta all'interno del campo, nel 1956.
L'atteggiamento negativo nei confronti dei profughi era esteso: le invidie per i sussidi che essi ricevevano, l'ignoranza e l'odio viscerale nei confronti del fascismo sfociavano in un sentimento popolare che si riassumeva nelle ripetute frasi: "Basta con questi profughi, è ora di finirla!". La CGIL arrivò ad organizzare scioperi e blocchi dei treni in arrivo dall'Istria con l'intenzione di impedire la presenza fisica di queste persone e di contrastarne materialmente la vita: una donna riferisce che si rifiutarono di darle l'acqua che lei chiese, sporgendosi dal vagone, per far bere il suo bambino. Una zaratina rivela che suo padre, nel 1949, andando a lavorare in un ufficio di Udine, ogni mattina si sedeva alla sua scrivania e trovava un biglietto con la scritta morte ai profughi. Al giorno d'oggi, alcuni dei miei intervistati ricevono ancora lettere anonime, o sono costretti ripristinare la tomba del proprio familiare, perché c'è chi si diverte a spaccarne la lapide, scrivendoci sopra sporco fascista (sono fatti accaduti tra 2003 e 2005).
Qual'è stato il maggior dramma per gli esuli: dimenticare il passato o ricominciare una nuova vita, assieme ai propri cari sopravvissuti alle repressioni nelle terre d'origine?
Una volta in salvo, la popolazione dell'esodo si rimboccò le maniche cercandosi un qualsiasi impiego: c'era chi -per esempio- pur essendo diplomato, lavorava al distributore di benzina. Istriani e dalmati provavano gran attaccamento verso quella loro Italia multietnica, fatta di famiglie imparentate con serbi o croati, eppure per ricominciare una nuova vita spesso si adattarono a sparpagliarsi tra varie città italiane, o a emigrare all'estero. In ogni caso, ciò che più pesò fu il dolore del ricordo, e di come furono costretti a rinunciare alla loro identità.
Avevano dovuto abbandonare i loro luoghi natali, dove avevano trascorso gli ultimi tempi nel terrore: sapevano della sparizione di italiani e dei sequestri dei figli di italiani. Passavano il confine con un documento ottenuto dopo mesi di attesa, un lasciapassare semiregolare o un certificato inventato di sana pianta. Lasciavano le loro proprietà dopo aver svenduto i mobili e portandosi dietro poche cose. Alcuni si mettono in viaggio con una valigia piccola piccola, c'è poi chi scappa con la legna da ardere, altri invece se la battono con i soli vestiti che hanno addosso. C'era anche chi scappava con gli animali da cortile: la mucca, la capra, le galline... al punto che Tito fece una legge che vietata di transitare con animali. Utilizzavano degli stratagemmi e, sia che la fuga fosse precipitosa oppure organizzata, i componenti delle famiglie si dividevano, in modo da sfuggire all'attenzione delle spie titine, alla polizia segreta dell'OZNA e alla rete di informatori divenuta onnipresente.
Siccome le genti di confine si mischiavano fra loro e gli sloveni fraternizzavano con gli italiani, a coprire il ruolo di granicari ("guardie di confine") Tito mandava esclusivamente serbi, croati e bosniaci, che avevano l'ordine di sparare su chi cercava di passare il confine. Così, c'è chi si avventura fra i boschi, chi scappa a nuoto, e chi con la barca a remi. E c'è chi, una volta al largo, sentito il rumore delle motovedette in avvicinamento, smonta la barca a vela, butta l'albero in mare, si nasconde sott'acqua e poi, scampato il pericolo di essere visto, rimonta la barca, continua la sua fuga di notte e, orientandosi con le stelle, approda sulla costa opposta dell'Adriatico. Sembra un romanzo di fantasia, invece è vita vissuta, che non compare sui libri di storia.









