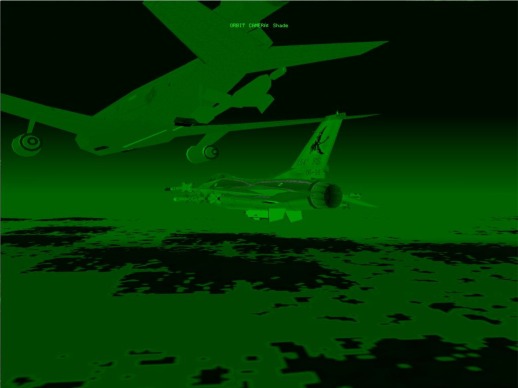
Caccia
Dalla costruzione del concetto di guerra umanitaria alla problematizzazione della presenza umanitaria. Riportiamo la presentazione ed il testo integrale di una tesi di laurea realizzata da Sergio Capitanio.
di Giacomo Bosisio
La guerra umanitaria è invenzione recente, risultato di un vero e proprio cortocircuito semantico e di un'operazione di propaganda veicolata da tutti principali media verso le opinioni pubbliche europee. Il retroterra culturale nel quale si sviluppa il consenso all'ingerenza umanitaria armata è, secondo la definizione di Danilo Zolo, la corrente di pensiero del "globalismo giuridico" che postula il superamento dell'ordine westfeliano, rimodulato sul nuovo assetto mondiale scaturito dal processo di globalizzazione e dalla radicalizzata centralità dei diritti individuali a unici principi costitutivi del diritto internazionale.
Su questa base teorica viene intrapresa nei mesi precedenti i 78 giorni di bombardamenti della NATO una grandiosa campagna di costruzione del consenso attorno alla decisione presa dalle cancellerie occidentali di intervenire militarmente nel conflitto serbo-albanese in Kosovo che agisce su più livelli: il riflesso di allarme che le guerre jugoslave degli anni '90 determinano nella memoria profonda del Vecchio continente a causa del riaffacciarsi dell'orrore nel cuore stesso dell'Europa, è ripreso e rrilanciato mediante un processo di banalizzazione dei ruoli (Milošević novello Hitler, la NATO come gli Alleati che ne abbatterono il regime e l'ordine nuovo) e degli eventi.
Protagonista indiscusso di tale processo è il medium stesso, la televisione ed in particolare il giornalismo televisivo, capace di cavalcare con estrema efficacia l'emotività del grande pubblico dei cittadini-spettatori e di operare un'apparente sospensione valoriale che dia loro la sensazione di scegliere liberamente per chi patteggiare nello scontro tra il tiranno genocida e le democrazie occidentali liberatrici. La spropositata attenzione televisiva, inveratasi in una copertura capillare di ogni singola fase dell'escalation, ha mostrato la sua capacità di influenzare addirittura gli eventi che avrebbe dovuto limitarsi a raccontare.
Nell'immediato dopoguerra, cavalcando l'onda emotiva propagatasi di recente, in Italia si tocca il paradosso: lo stesso Governo che ha appena mosso guerra, decide di promuovere la pace lanciando un appello e una sottoscrizione ai cittadini. Nasce la "Missione Arcobaleno" cui aderirà un numero altissimo di donatori privati e che innescherà un dibattito a tratti molto amaro tra le ong circa l'opportunità di utilizzare per il finanziamento di propri progetti, fondi di provenienza così ambigua. Da un punto di vista più generale, in questa fase si ratifica il superamento della tradizionale (e per molti versi discutibile) cooperazione allo sviluppo, sin qui perno della politica estera occidentale verso i paesi in via di sviluppo, in favore dell'ideologia umanitaria che comporta un approccio emergenziale a qualsiasi contesto di assistenza, che si esplica nel ricorso a procedure standard d'intervento attuate da professionisti dell'aiuto umanitario.
Dal giugno del 1999 il Kosovo è sospeso nel limbo istituzionale previsto dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rientrate dalla finestra sulla scena del conflitto serbo-albanese dopo essere state estromesse da qualsiasi ruolo di mediazione della crisi. La tesi analizza e descrive la situazione nella regione di Pejë/Peć (secondo la doppia dizione attualmente in uso e politically correct), nel Kosovo occidentale, epicentro degli scontri più duri tra UÇK e le forze di sicurezza di Belgrado. Si analizzano ruolo e prerogative dei vari attori del panorama umanitario e le contraddizioni che la loro ingombrante presenza innesca sul precario sistema economico locale. Le distorsioni che il circo degli aiuti produce sul mercato immobiliare e su quello del lavoro, il meccanismo di "infantilizzazione" e assistenzialismo in cui precipita la locale società civile sono solo alcuni degli effetti più percepibili nella Pejë/Peć del dopoguerra. E il ruolo del personale umanitario che ha invaso la regione spesso fatica a tradursi in utilità per la popolazione locale, inverandosi semmai pratiche di vita separata (nonostante le accese rivalità tra le organizzazioni, spesso incapaci di qualsiasi coordinamento), scandita da cerimoniali e (cattive) abitudini che tendono fatalmente all'appiattimento, in questo amplificate dalla standardizzazione delle attività e dalla gestione esclusivamente manageriale dei progetti.
Un isoformismo istituzionale che si innesta su un situazione compromessa da un inquietante difetto d'analisi della Comunità internazionale la quale, in mancanza di qualsivoglia radicamento territoriale, ha agito per imposizione di modelli esterni, effimeri ed improponibili in Kosovo. La schizofrenia degli internazionali, da un lato magnanimi dispensatori di abbondanti aiuti, dall'altra spietati fagocitatori di qualsiasi specificità locale, ha creato un meccanismo di dipendenza, non solo economica, dall'occidente. Il personale incaricato di attuare i progetti di sviluppo e di democratizzazione non si è dimostrato all'altezza della situazione, nonostante la lista dei titoli accademici dovesse suggerire altro. Appare davvero inusuale che, mentre veniva varata la più grande missione delle Nazioni Unite, non sia stato valutato l'impatto della presenza internazionale e le sue eventuali ricadute.
La terza parte della tesi descrive la vicenda di "Bergamo per il Kosovo", piccola organizzazione che iscrive la sua azione nel solco dell'innovativa prassi della cooperazione decentrata intesa in senso ampio. I suoi animatori si propongono di evitare gli errori testè descritti dai "mostri sacri" della cooperazione elaborando un approccio critico ai progetti di assistenza alle popolazioni locali mirante a intessere una trama di scambio e partecipazione tra comunità locali organizzate. L'attore principale di questi partenariati è la società civile, che a sua volta si dimostra in grado di coinvolgere le istituzioni e gli enti locali, e non viceversa. L' istituzionalizzazione viene mantenuta a un livello minimo, che lascia ampia possibilità di espressione alla spontaneità e alla capacità dei soggetti coinvolti di autorganizzarsi. Erede del "Comitato accoglienza profughi ex-Jugoslavia" attivo a Kakanj (BiH), lo staff di "Bergamo per il Kosovo" giunge nella provincia tre giorni dopo la fine dei raid NATO ed è tutt'oggi presente. Architravi della sua presenza sono il radicamento territoriale (nella Vallata di Radavac, alle porte della città) e il rilievo dato al coinvolgimento della comunità bergamasca mediante frequenti e numerose missioni di volontari che, forti della propria terzietà, diventano artefici e protagonisti di una fitta trama di relazioni personali.
La conoscenza personale permette, attraverso la confidenza, di relativizzare l'irriducibile asimmetria del rapporto di cooperazione classico. In questa caratteristica risiede la forza del volontario, che viene percepito dalla comunità locale come sì come"internazionale", ma dotato di scarso potere, quasi nullo. Questa caratteristica spoglia il volontario del suo ruolo e avvicina, predispone all'incontro, come la sobrietà dei mezzi e della struttura dell'organizzazione. Coerente con questo approccio è la scissione mai ricomposta tra il ruolo e il significato della presenza di "Bergamo per il Kosovo" nella Vallata e nella Municipalità e il suo riconoscimento formale (l'organizzazione non ha tutt'oggi personalità giuridica), come del resto la metodologia del self-help nella gestione dei progetti di ricostruzione. Siamo di fronte qualcosa di simile ad un buon esperimento dilettantistico in cui la prestazione è valutata in termini di efficacia nel tempo e di qualità del proprio operato. Nonostante fugga il criterio dell'efficienza, l'organizzazione bergamasca si trova però ad agire in un mercato deregolamentato, e deve adeguarsi a questo contesto per poter operare. Il progetto di rientro in cui essa è attualmente impegnata le dà l'occasione di compiere un ultimo importante sforzo nel difficile tentativo di costruire pace in un'aera lacerata da un conflitto profondo e violento che qualcuno pensava di poter sanare mediante ottocentesche conferenze di spartizione d'aree d'influenza e bombardamenti da diecimila metri d'altezza.






