
Un sorriso per la Bosnia, campo profughi di Ilirska Bistrica, 1993 (Cercavamo la pace OBCT )
Un romanzo corale, ma anche un romanzo dei sentimenti e un inno al volontariato. E' "I fiori si bagnano di venerdì" di Marzio Biancolino, che ci porta in un campo profughi allestito in Slovenia durante le guerre di dissoluzione della Jugoslavia. Intervista con l'autore
“I fiori si bagnano il venerdì” è un bel romanzo, opera di Marzio Biancolino, edito dalla Oltre Edizioni. Racconta la storia di Massimo, un volontario che da Milano va in Slovenia per aiutare i bosniaci in fuga dalla loro terra in guerra e riparati nel campo profughi di Ceško.
La rappresentazione, molto aderente alla realtà della vita del campo, delle relazioni tra internati e volontari, testimoniano una esperienza personale, tanto da sospettare una proiezione dello stesso autore nel personaggio di Massimo che, non a caso, per gran parte del romanzo diventa anche l’io narrante dello stesso, imprimendo alla scrittura una singolare intensità.
Marzio Biancolino, quanto possiamo considerare autobiografico questo tuo romanzo che rivela un alto tasso di conoscenza della materia che tratta e, soprattutto, partecipazione emotiva?
Buona parte della vicenda narrativa sulla quale poggia “I fiori si bagnano il venerdì” trae spunto dal progetto umanitario “Un sorriso per la Bosnia” (Uspb), ideato nei primi Anni ’90 da Gioventù Aclista di Milano, al quale ho avuto la fortuna di aderire.
Si trattava di un’iniziativa dai contenuti davvero peculiari (dove, cioè, la condivisione della condizione del rifugiato prevaleva sull’aiuto materiale) per dare supporto, attraverso una rete di gemellaggi, a oltre una ventina di campi profughi sloveni. A trovarvi rifugio erano soprattutto bosniaci in fuga dall’espansionismo serbo di inizio conflitto.
La modalità letteraria del mio libro non ha comunque niente a che vedere con un saggio su come è nato, si è sviluppato o quale ruolo abbia avuto Uspb nel panorama del volontariato italiano di quel tempo. “I fiori si bagnano il venerdì” è una libera rielaborazione di quel fenomeno solidaristico, rivendicandone un’autonomia storica suggellata, per esempio, da località in Slovenia e in Bosnia che, portando nomi di fantasia, rappresentano il compendio di luoghi diversi dei quali sono stati attinti aspetti significativi per la narrazione. (Come peraltro “confessato” nella Postfazione.)
Anche da un punto di vista cronologico, la maggior parte del romanzo si svolge in un periodo, cioè nell’agosto 2002 in Bosnia, in cui il progetto Uspb si era storicamente e amministrativamente esaurito da quasi un lustro.
Per una ventina di anni questo mosto narrativo è rimasto quietamente a fermentare in un angolo della mia mente, alimentando comunque la consapevolezza che prima o poi avrebbe raggiunto la dovuta maturazione per sprigionare tutta la sua valenza formativa. E questo è successo nel settembre 2013, quando ne iniziai il travaso dai meandri cerebrali a quelli letterari, e per Pasqua 2014 sono arrivato a ultimare la prima stesura del romanzo. Operazione durante la quale, pur nel rispetto di quanto finora detto, non ho indugiato a recuperare aneddoti, spunti e circostanze della mia esperienza diretta, da porre al servizio di una fantasia che avesse il massimo rispetto della plausibilità e della coerenza storica.
Massimo e Jana sono i due protagonisti, ma anche gli altri, da Adnan a Gloria, da Alina a Zlatko e gli altri non li possiamo chiamare comprimari. È quasi un romanzo corale, se vogliamo, o ti sembra esagerato visto che in quarta di copertina lo si definisce “un romanzo di sentimenti”?
Quando sento parlare di coralità, riferita a questo mio romanzo, mi si apre il cuore perché è proprio uno degli obiettivi che mi ero proposto e che quindi devo aver centrato. Una coralità che non è affatto in antitesi con il “romanzo di sentimenti” quale è dichiarato in copertina.
Massimo e Jana sono, scusami la forzatura concettuale, una sorta di primum inter pares, condividendo, insieme ad altri otto personaggi, il ruolo di “Scheggia” nella prima parte del romanzo in cui si delinea il palcoscenico narrativo. È poi vero che, dalle primissime righe del libro alle ultimissime, sarà la loro complicata vicenda personale a fungere da fil-rouge attraverso svariati e sorprendenti accadimenti, ma i sentimenti si snocciolano ripetutamente anche ben al di fuori della loro vicenda privata.
Ci sono gli amori, più o meno corrisposti, presunti o traditi, tra volontari e profughi. C’è l’amore dei profughi verso la propria terra, da cui sono dovuti fuggire per salvarsi la pelle e alla quale non sanno se potranno mai più tornare. Un sentimento, questo, non standardizzato bensì temprato su proprie insindacabili sensibilità, cosicché c’è quel profugo che coglierà la prima opportunità per rifarsi un’esistenza all’altro capo del mondo, magari in Australia, e chi, all’opposto, non rinuncerà mai al sogno di fare ritorno al paesello natio, incoronando infine la propria cocciuta perseveranza per sfidare apparenze e contingenze decisamente malevole.
E permeato da una guerra tanto sanguinaria, c’è anche l’amore dell’uomo verso la propria specie: l’amore sostentatore, nobilmente declinato in solidarietà, che emana inesauribile dall’azione umanitaria dei volontari. Per questo, forse immodestamente, mi piace definire “I fiori si bagnano il venerdì” una sorta di inno al volontariato.
Il tuo romanzo, diviso in tre parti, ha due punti di vista: una prima parte in terza persona, le altre due in prima persona. Mi interessa la motivazione narrativa di questa scelta…
Questa soluzione ibrida, riguardo al narratore, si è andata rivelando e affermando strada facendo, e volentieri l’ho assecondata in corso d’opera. Punto fermo era la suddivisione del romanzo in tre parti secondo una metafora bellica: Shrapnel (10 Schegge), il Lancio, gli Effetti.
Delle Schegge, ognuna dedicata a un personaggio, ho già accennato in precedenza. Nel loro insieme, e sganciate da una rigida continuità temporale, sono dieci tasselli che contribuiscono a creare il complesso quadro d’insieme di Korljevo nell’agosto 2002, il villaggio d’estrazione musulmana ma finito nell’entità politico-territoriale serba in seguito agli accordi di pace del 1995.
Il Lancio è il lunghissimo flashback centrale che, da poco prima che scoppiasse la carneficina jugoslava, ci porta alla Korljevo postbellica. Gli Effetti ci accompagnano con qualche passo faticoso e incerto nella nuova vita del redivivo villaggio bosniaco, per mano alla complessa storia fra Jana e Massimo con la quale abbiamo nel frattempo familiarizzato e che necessita di uno sviluppo.
Dopo aver dato avvio alla seconda parte del romanzo continuando a scrivere decine di pagine in terza persona, mi sono reso conto di ritrovarmi creativamente imbrigliato in quella modalità, che mi pareva mortificasse una certa centralità che avevo previsto per Massimo. Così ho riscritto tutta quella nuova parte in prima persona, attribuendo a questo personaggio il privilegio del suo punto di vista narrativo.
A quel tempo il titolo di lavoro era “Uno di voi”: Massimo avrebbe subito pesanti tracolli affettivi, economici ed esistenziali che lo avrebbero portato a una immedesimazione patologica con la condizione del profugo, e a gestire in terza persona tutto ciò, mi pareva di scrivere con una matita spuntata.
Il risvolto di copertina del libro - in cui ti presenti - rivelano una biografia molto simile a quella degli scrittori americani del primo Novecento, venditore di enciclopedie, operaio alimentare, chimico industriale, cameriere, vicecuoco, fino a quando non approdi alla editoria e poi alla scrittura. Il campo profughi di Ceško come si situa in questo tumultuoso contesto?
La scrittura è arrivata prima che io approdassi, nei primi Anni ’90, al mondo dell’editoria. Quel “tumultuoso contesto” (leggasi “rito di passaggio” dalla mia formazione chimica alla destinazione finale) ebbe luogo nei miei Anni ’80 in cui molto lessi con occhi avidi e foderati di un candore estremo, così disinvolto da farmi ripetere: “Ma in fondo, che cosa ci vuole a buttar giù un romanzo?”.
Tra i riferimenti più stimolanti del momento avevo i Tropici di Henry Miller o certe vette di García Marquez! Per un curioso caso del destino, l’inizio del mio massiccio processo di raffinazione letteraria e l’interesse per le cruente vicende jugoslave che tanto mi avrebbero segnato umanamente, interiormente e artisticamente fino al Ceško di questi giorni e altre iniziative “cugine”, sarebbero stati pressoché concomitanti a inizio Anni ’90.
Oggi, 30 anni dopo quella tua esperienza, cosa rappresenta quell'esperienza? Un capitolo della tua vita, come quello del cameriere o del correttore di bozze, o qualcosa di più?
Sarebbe riduttivo connotare come “capitolo” il mio interesse verso quel mondo. Le esperienze vissute hanno avuto in me un alto tasso formativo, sia per gli straordinari incontri umani di quegli anni (dai profughi ai volontari, agli operatori vari), sia per il mio percorso personale che mi ha visto prima come volontario “semplice”, quindi come responsabile di gemellaggio e infine, sull’esaurirsi di Uspb a fine Anni’90, come membro della segreteria nazionale.
In quest’ultimo ruolo ho addirittura partecipato a una missione ristretta a Lubiana per trattare la concessione di alcuni fondi da parte della fondazione del “fantomatico” George Soros. E a legare e connettere il tutto come collante magico e supremo – a partire dal mio romanzo, che ne è permeato, fino alla mia rinnovata sensibilità verso le cose della vita, tanto le pubbliche quanto le private – un insegnamento che è il Primo Comandamento in cui si imbattono i nuovi volontari nel corso di formazione di Jana, passaggio obbligato cui devono sottostare prima di partire per il campo profughi di Ceško.
Si rifà al pensiero dello psicanalista austriaco Bruno Bettelheim (1903-1990), deportato a Dachau e Buchenwald. Così recita: “Nessuno può far fronte a una catastrofe e sopravvivere a essa, se non ha la sensazione che la propria sorte stia a cuore a qualcuno”. Leggendo il romanzo, si potrà comprendere appieno tutta la taumaturgica esplosività di questo semplice concetto.
Tuttavia, come piccola appendice sul tema, posso da subito narrare un preziosissimo aneddoto. Poco più di un anno fa, sulla pagina di FaceBook che ho dedicato al romanzo, è apparso un post firmato da quella che una trentina di anni prima era una ragazzina di circa dieci anni, fra le più attive del campo sloveno del nostro gemellaggio. Il post recitava: “La cosa interessante è che i ricordi associati a quella parte della mia vita sono pieni di socializzazione, risate, giochi... E mi riempie il cuore quando vedo tutti quei bambini di allora diventati adesso adulti, persone felici, di successo e soddisfatte.” Ebbene… il buon Bruno aveva avuto pienamente ragione!
Cosa ti aspetti dal tuo futuro? O, come si dice, guardando ai tuoi ricchi trascorsi, ci dobbiamo aspettare altro?
Quanto al mio futuro letterario, ho ben tre romanzi nel cassetto, pressoché pronti. A uno in particolare sono molto legato, il più recente, che narra le quotidianità di un piccolo gruppo di amici trentenni di Nembro e Alzano Lombardo… Sì, proprio il famoso triangolo rosso della mancata chiusura totale nella Bergamasca nelle primissime settimane dell’esplosione del Covid.
L’arco temporale della narrazione è molto ridotto, ovvero dalla fine febbraio del focolaio di Codogno al 12 aprile di Pasqua, quando si toccò il primo picco dei contagi con l’illusione che fosse iniziata la discesa e con l’arrivo dei vaccini per Natale tutto sarebbe finito disinvoltamente alle nostre spalle.
L’intento narrativo è quello di voler cristallizzare nelle pagine del romanzo tutte le paure, le illusioni, le angosce, le speranze, le ipocrisie, le ingenuità, gli scandali di quei giorni, visti con gli occhi di chi sta passando attraverso una guerra dalle caratteristiche mai sperimentate prima. E cercare di far capire quello che purtroppo non si è ancora voluto capire.
Se poi avessi tempo e risorse per scrivere un romanzo nuovo, si tratterebbe di qualcosa di molto storico che mi solletica da ormai vent’anni. Creo un po’ di suspense con una domanda la cui risposta tengo per il momento per me: “Vi siete mai chiesti perché, con l’avvento del periodo post-coloniale africano, nei nomi delle megalopoli è stata fatta tabula rasa di tutti i riferimenti a esploratori, regnanti o politici occidentali, con l’unica eccezione di Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, fondata nel 1880 dall’esploratore italiano Pietro Savorgnan di Brazzà?”
Inoltre, in questi ultimi due mesi ho ideato un evento cultural-musicale di supporto a una raccolta di fondi per Linea d’Ombra ODV, l’associazione di Trieste che si prende cura di migranti, soprattutto afghani, pakistani, siriani, bengalesi, che riescono a giungere in città dalla Rotta balcanica. L’evento si intitola “Genti diverse venute dall’Est: da De André alla Rotta balcanica.” Si tratta di una sorta di esercizio in caccia di quelle citazioni dalla poetica di Faber che ci fanno immaginare che cosa lui oggi canterebbe sui migranti, categoria di diseredati totalmente assente nei suoi testi al tempo della sua dipartita in quanto non ancora agli onori della cronaca per come la conosciamo oggi. Il debutto è stato una decina di giorni fa con ottimi risultati di pubblico e donazioni.
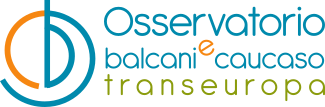






 To Top
To Top