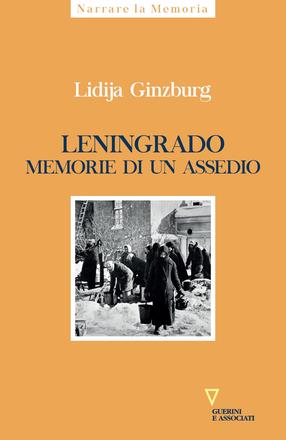Monumento agli eroici difensori di Leningrado-San Pietroburgo © Shutterstock
Un diario in forma di romanzo, in cui Lidija Ginzburg racconta la sua città, Leningrado, sotto assedio. I minuscoli atti che si susseguono in uno sforzo mastodontico quotidiano per il diritto alla vita. Una recensione
Esce, per la Casa Editrice Guerini e Associati, il secondo volume della collana Narrare la memoria: Leningrado, Memorie di un assedio di Lidija Ginzburg, testimone oculare sopravvissuta all’evento. Dopo Inseparabili - Due gemelli nel Caucaso di Anatolij Pristavkin, viene presentato un altro tassello della Seconda guerra mondiale, che porta il lettore, questa volta, all’estremo nord della Russia, a Leningrado, nel pieno dell’assedio. I due volumi, ambientati più o meno negli stessi anni, in un lasso di tempo quasi sovrapponibile (il racconto di Pristavkin è ambientato nel 1944, l’assedio di Leningrado va dal 1941 al gennaio 1944) sono complementari: dal sud al nord, dall’estremo caldo all’estremo freddo, dal dinamismo alla staticità, dal lungo viaggio unilineare senza ritorno in treno a un tragitto di andata e ritorno ripetuto in uno spazio confinato, dall’infanzia degli orfani all’arrovellarsi della classe intellettuale, dall’abbondanza delle mirabelle spontanee alle miserrime razioni di kaša, le due narrazioni mostrano due pagine distinte dell’Unione Sovietica staliniana durante la Seconda guerra mondiale.
Gli 872 giorni dell’assedio di Leningrado, la città simbolo della resistenza ai nazisti, sono analizzati e narrati non in una dimensione altisonante, epica e aulica, ma nella quotidianità dei gesti che assicurano, giorno dopo giorno, la sopravvivenza del singolo, il cui pensiero ruota attorno ad un unico assillo: quello di evitare la distrofia e la morte per fame, in una Leningrado bombardata regolarmente, e stretta nella morsa del gelo.
Gli atti giornalieri vengono scomposti nei singoli passaggi e movimenti, come in un quadro cubista. La dinamica dei movimenti viene disassemblata in una descrizione minuziosa quasi fisiologica: “Le coperte erano pesanti, e quello che era peggio, continuavano a scivolare e a cadere da tutte le parti. Per trattenere il mucchio, si doveva impiegare uno sforzo muscolare appena all’inizio percettibile, che però alla fine diventava faticoso. Si doveva imparare a dormire senza fare il minimo movimento, ben distesi, con la gamba piegata in modo particolare per trattenere la base di tutto quel mucchio di coperte. Altrimenti tutto quanto poteva scivolare di colpo sul pavimento implacabilmente. E allora, nel buio, nel freddo assassino, dovevi ricostruire l’edificio, oramai del tutto instabile e inutile. Non potevi stendere le braccia o alzare le ginocchia nemmeno un po’ sotto la coperta o girarti improvvisamente per premere la faccia sul cuscino. Vale a dire che né il corpo né i nervi potevano mai riposarsi”. Al posto di una persona intenta a coricarsi, viene quasi spontaneo visualizzare un ammasso di membra e altre parti del corpo in tensione.
La prosa della Ginzburg non é di facile lettura. Ció é dovuto, non tanto e non solo alla tragicità dell’argomento, quanto alla natura proteiforme della sua scrittura, che cambia sovente registro, richiedendo, a ogni mutamento di stile e di tono, un adeguamento dell’attenzione e una sintonizzazione alla frequenza. L’intero libro è costruito su un ossimoro: la quotidianità vissuta in condizioni estreme, e la necessità di perseguire tale quotidianità per non soccombere a quello che la Ginzburg definisce “il nichilismo dell’assedio”.
Si passa dall’espressione colloquiale: “Un giorno il sale era sparito dai tavoli, e la kaša venne servita insipida. A. cadde nella disperazione. Correva di tavolo in tavolo mormorando: «Non si può mangiare la kaša senza sale... non si può proprio... ». Era un brutto segno. Un giorno V. arrivò alla mensa con un grosso buco sul davanti del suo soprabito. Non ne diede una spiegazione. Una donna accanto a lui all’improvviso fece cadere un cucchiaio di olio di girasole dalla sua kaša dentro uno dei suoi piatti sporchi. «Lei è una vera sprecona» sentenziò con tono salottiero V. raccogliendo l’olio col suo cucchiaio, e lo inghiottì.” Alla meditazione filosofica: “Non la sostanza metafisica, non l’anima uguale a se stessa del XIX secolo, ma piuttosto un mutamento infinito di situazioni, che provocano reazioni e riflessi a catena. Comunque sia, si trattava di un sistema biologico e sociale consolidato che riappariva ogni volta come un complesso organico che tuttavia continuava a sorprenderci sia per l’immutabilità dell’essere umano che non dimentica nulla e non impara nulla, sia per la sua volubilità.”
Il tema centrale dell’opera si focalizza sulla distrofia e sul problema dell’alimentazione, sviscerato in tutte le sue sfaccettature. Pagine e pagine dedicate alle file in mensa, dove il ritmo della descrizione è talmente lento da riprodurre la lunghezza dell’attesa, le discussioni in coda, le paure della truffa sulle porzioni, il funzionamento e i prezzi del mercato nero, il rituale della razione di pane e le differenti procedure per consumarlo, i pro e contro dell’avere o non avere una famiglia da sfamare, la superiorità dell’intellettuale per cui il cibo non può essere una questione vitale, ma di status symbol. “Inoltre l’individuo era classificato secondo il suo gruppo di appartenenza e le reazioni peculiari del singolo strato sociale di fronte alla tragedia del cibo. Tra queste, vi era la reazione tipica degli intellettuali degli anni Trenta, uomini e donne, più o meno giovani, che tendevano a dedicare il minor tempo e la minor energia possibile alle faccende della vita quotidiana. In quella cerchia, non era permesso interessarsi al cibo in quanto tale, ma soltanto ai suoi risvolti psicologici: conforto, riposo, conversazione amichevole (accompagnata da un bicchiere di vodka) il progetto di una cena con una ragazza. Altrimenti l’interesse verso il cibo avrebbe costituito il segno di una dipendenza di infimo ordine.” O ancora: “ – Sa, mia madre è morta – disse la donna fermando un uomo che conosceva appena, - la kaša é quella dei suoi tagliandi... Sono così infelice, è incredibile. Non posso farci niente. Pensavo a come sarebbe stato fantastico mangiarne tre o quattro porzioni tutte in una volta... E invece non funziona, non ne ho voglia... Continuo a ingoiarla perché mi sento profondamente infelice. Cerco di pensare che andrà meglio, che la kaša, tutta questa kaša scenderà dentro di me e soffocherà l’infelicità, la cancellerà, la guarirà. Mangio e mangio, ma l’infelicità non se ne va.”
Il testo, infine, è denso di riferimenti letterari diretti e indiretti. Fra i riferimenti diretti, i più frequenti richiamano Tolstoj: “ Tolstoj in Infanzia scrisse di sua zia Ergol’skaja, di come era gentile e di come egli non riusciva a ricordarla senza sentire rimorso perché a volte, a causa della sua timidezza, si era rifiutato di darle del denaro per comprare i dolcetti che lei amava tenere a disposizione per offriglieli, cosa che la faceva sospirare con tristezza. «E io negavo a lei, proprio a lei fra tutti quel piccolo piacere...». I sopravvissuti distrofici avrebbero pagato un duro prezzo per provare gli stessi rimorsi di coscienza di un ricco proprietario terriero.” I riferimenti indiretti popolano invece le discussioni all’interno della Redazione letteraria teatrale del Comitato delle Comunicazioni Radio, (fu un incarico al Comitato della Radio di Leningrado che permise alla Ginzburg di sostentarsi durante l’assedio e quindi sopravvivere): “ – No, questo non può accadere facilmente con la nostra bella lingua russa. A. Dice che questa è la tematica di Bierce. Per me è alquanto russa. Il testo non è scritto neanche con la lingua di Gor’kij perché la lingua di Gor’kij è più colorita. Direi che assomiglia di più a quella di Kuprin.”
Nel libro l’epopea della blokada è raccontata attraverso una serie infinita di minuscoli atti che si susseguono in uno sforzo mastodontico quotidiano, per il diritto alla vita, dove è la somma delle resistenze individuali che produce il risultato della vittoria finale:
Leningrado, Memorie di un assedio di Lidija Ginzburg,Il nemico voleva ucciderci, ma noi eravamo vivi, voleva uccidere la città ma la città sopravviveva, e io non ero che una particella quasi inconsapevole di quella vita che opponeva la sua resistenza.